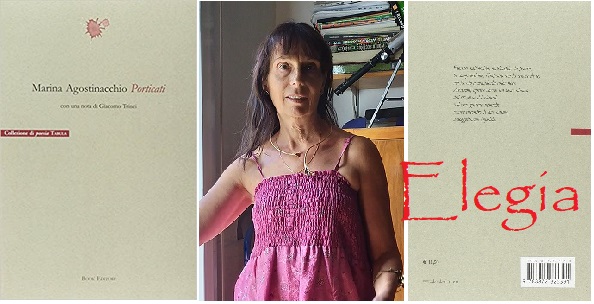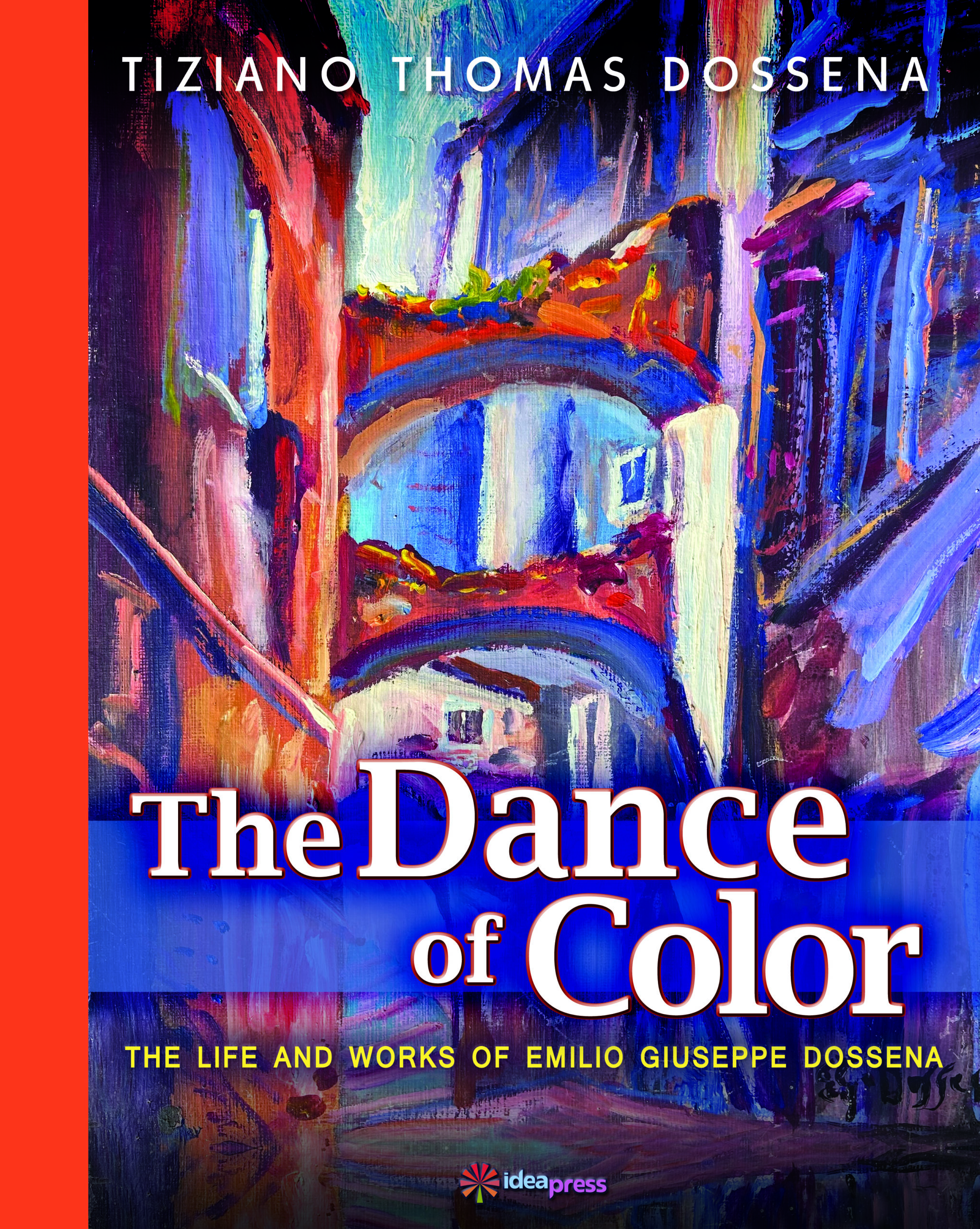Pubblicato nella raccolta di poesie Porticati il 4 settembre 2006 nella collana di poesia Tabula- Book editore- diretta e curata da Massimo Scrignoli.
Pubblicato nella raccolta di poesie Porticati il 4 settembre 2006 nella collana di poesia Tabula- Book editore- diretta e curata da Massimo Scrignoli.
Corredato da una nota di Giacomo Trinci sospesa tra analisi linguistica e suggestioni evocate dalla Bohème di Puccini, il libro raccoglie sette sezioni tematiche di cui una centrale, Elegia, già apparsa sulla rivista Poesia di Crocetti del dicembre 2004.
Elegia
Sono dieci gli anni, l’anima trivellata,
lo iato. L’eloquio sussurrato.
Nel tuo riposo fingo di appoggiare
ogni mia pena, la breve felicità,
le dispute della vita e tu che ascolti.
…………………………………….
Non ti ho mai detto gli anni dopo Daniele,
gli anni del figlio che succhia latte e ossessione.
La mia struttura, padre, che si deteriora,
ch’era già germe, una filatura,
crepa che s’apre nel gorgo del venire.
Era paura di guardare il male,
quello che spalanca inevitabilmente
da cellule — dicono indifferenziate-
per me senza gioia, l’allegro stare,
la leggerezza di essere e accettare.
Era lo spazio fra le ore, l’eco che manca,
l’anima che si ascolta e parla, crede
presagio quel riflesso di luce prolungato,
silenzio che s’allarga, crea la voragine,
muto restare, ombra prima ancora di andare.
Erano, padre, gli anni del progettare,
quelli che hanno il bene e l’aspettare,
il sogno, la danza. Il segreto guardare
i figli nel sé che avanza. Indietro, invece,
indietro, era la nostalgia del ritornare.
Anima amata, anima che sperava
non andassi via. Che rimanessi
a placare il vento della sera.
I sogni teneri e malvagi, le grida,
la dama bianca che bacia e si allontana…
Avrei voluto accarezzare il tuo dolore
per anni ed anni, spaccare il cuore,
nell’antro delle stanze cercare e ricomporre
la sposa che riposa, la figlia mai partita.
Darti i segreti, dirti le speranze ancora.
Invece sono andata, non una volta,
ma dieci e cento t’ho lasciato sulla terrazza
a salutare, la testa china tra le piante,
la mano ferma che si allontana,
la curva della strada che separa.
…………………………………
Dimmi se la notte è quell’assoluto blu
d’acqua o di galassia, là nella terra bruna
là dove ti hanno confinato
gli spiriti del pianto e del dovere.
Dimmi se è pietra o molle seme la dimora.
Tenero padre, non t’ho mai detto il pianto,
in altra notte, sul cuscino da poco abbandonato
da lei, la madre, ancora di respiro,
nel breve sonno, ancora voce.
Né sai le dita tra i capelli ch’eran miei.
Il buio, il pianto, il tuo lamento
cadono nel vano della stanza
dove i corpi prendono riposo,
la mente accoglie da qualche parte
quello che eri, giovane, senza lei.
Per tanti anni solo, muto ragionare
era il segreto della convivenza
col mondo sopra le nuvole, il brulichio
degli esseri tra felicità e dolore.
Su tutto un velo in forma di fantasma.
………………………………………
Tempo, tempo che non perdona
che non allevia lo stridulo lamento,
tempo che si consuma per generare
l’assenza, il vuoto, la lettera mai scritta.
Tempo che esiste solo nel sogno, nella testa.
Mi chiedo, padre, perché ho sprecato tempo,
se alle parole potevo tessere
fili più resistenti di colori
e, andando, la nostalgia, il pianto
fossero pietre d’impasto d’alba e della sera.
……………………………………………
Lascio che affiorino i ricordi calmi,
uno su uno li distendo
sul tuo lenzuolo ricamato, fresco di lino
quello delle estati, della tua sposa
il suo corredo, a cifre O.M. ab aeterno.
Stendo le lenzuola, quelle che m’hai lasciato,
nella tua stanza bianca; t’incontro, padre,
distesa su quel lino e mi accarezzi,
mi consoli, sei l’unico che perdoni
la figlia mai cresciuta, la pazza sognatrice.
Perdona, padre, quello che sono,
i tradimenti, la poca luce che s’irradia,
l’indugio di questi anni quaranta,
la lontananza dagli insegnamenti.
Sono tua figlia, la ribelle, che ancora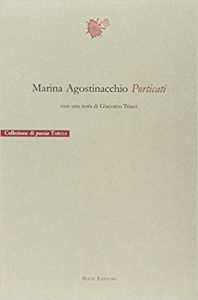 mostra
mostra
appesi al muro. Non una lacrima,
la mano al cambio, l’occhio che rifiutava
confondersi al lucido seta del vestito.
Era il rito del lasciarmi lì al portone
della scuola, l’infanzia che tornava,
come se avessi fretta d’abbandono:
il giro dei pazienti, l’ospedale,
la sala operatoria ora una finzione.
Il giorno delle mie nozze, un giorno da barrare
perché velocemente tutto restasse uguale.
Sono tornata dopo e t’ho trovato
seduto, ad aspettare, contento
delle briciole d’amore che potevo dare
…………………………………………
Quella volta mi hai ingannata, lasciata,
sola ad ascoltare il canto, l’ultimo atto
della Bohème; lei, mia madre,
moriva veramente, col filo della sua voce
era Mimì, era il suo nome, era il distacco lento.
…………………………………………………
L’ultima estate sono tornata,
aperto imposte, cambiato l’aria,
perché fossimo felici insieme
tu, io, il bimbo ch’ era il nuovo, la speranza.
L’ultimo tempo che non sapevo ultimo.
Cantavi allegro, il passo rinnovato
di buon mattino, l’odore del caffè,
la rosa, il bacio ad annunciarmi il giorno.
E non sapevi il male che t’era dentro,
diverso da quel male d’anni, forse figlio.
Era settembre, l’oro dell’uva, il cuore d’oro
a spigolare il grano, tra le tue mani
la figlia ritornata, la figlia appesantita;
leggerissima la figlia, la mente,
l’anima di vento prima di ripartire.
Settembre, la curva dell’estate,
l’orlo della mia vita, sull’orlo in due.
Friniva lentamente la cicala,
friniva mortalmente, lasciavi
la poltrona, i giorni confidenti le paure.
Non t’ho più visto ragionare,
posare gli occhi sulle dita scure
i piedi gonfi, chiamare aiuto
a districare i dubbi sul tuo male.
Tu l’alleanza ritrovata con la vita.
………………………………….
Padre, non t’ho più sentito,
lontano, la patria, il cuore in un altro nido,
solo dopo giorni, la voce, per me un grido.
Non me l’hai detto, ma già sapevo il male.
La scelta d’esser solo e disperare.
I giorni in un letto d’ospedale, solo,
l’uomo diviso, medico e paziente.
Padre nel tuo Getsèmani incantato,
lussureggiante luogo d’agonia.
Padre nel tuo novembre piagato.
Quali i pensieri, le decisioni, le preghiere,
quante le sere a decifrare il senso
del tuo male. Ora ti vedo, ti penso
scena su scena in linea al tuo dolore.
Ora ti chiamo, ti corro incontro, ora che so.
Tornando a casa la città nelle cose opache,
fredde, raggela la speranza.
Tu nel cappotto dici la sentenza,
tu dici come fare, spieghi le ragioni,
la partenza. Non un soffio di tremore.
Gli ultimi atti, soli, sprofonda nei tuoi occhi
la verità, la tua paura; la morte
viene, arriva. Cerchi protezione,
dici se ci sarà clemenza, un po’ d’amore.
Il ventre ingombro, mi allargo a dar consolazione.
Gli ultimi atti i pranzi, le partenze
i fine settimana, prima del confino.
Verona, Borgo Trento che ossessione.
L’ultimo atto è sera, dicembre scuro,
la macchina che t’inghiotte dietro le veneziane.
…………………………………………………
La voce, la voce che invoca aiuto.
Che aiuto, padre, ti potevo dare.
Lontana, erano braccia sottili, e dita
più affusolate le mie che ti avvolgevano
nel sonno disturbato, nel gelo delle arterie.
Eccoti arrivato, la fine del calvario,
il corpo martoriato, la crisi,
il soffocamento. Ma lì su quel letto,
la stanza fuori dalla vita, eri perfetto.
Composto nel rigor mortis, te n’eri andato.
……………………………………………
Non ho potuto accompagnarti oltre il confine,
al campo, dirti parole d’angeli,
accarezzare il cuore. Tra noi lo spazio,
la stessa ora, l’ansia, il terrore.
Io non ombra che precede dentro la visione.
Avrei voluto sciogliere lentamente
l’anima dai legacci, scortarla
al limite del divieto, rimettermi
nel cammino sola, e tu
nella paura non fossi abbandonato.
Del dopo muto il cuore,
silenzio della neve,
rigidi i vetri della casa,
gli atti d’amore.
La vita è fastidio, morsa, dolore.
Il peso delle parole nel trasloco
più delle pesanti travi scardinate,
meno ingombranti delle idee, dell’aria che consumo.
Verso il ritorno, dall’avvenire all’involuzione,
riaccendere la vita nella casa fredda.
Le parole dette e riascoltate,
le ultime e le lontane andate,
fuori dal suono, dal timbro particolare
quello che avevi ed eri tu, il segno,
l’azzurro, l’oro, il prisma, i colori che rimbalza.
Mobili tuoi, cose che ammassano gli spazi
che hai visto altrove, costrette, ritrovate.
Tu voli in tutto, cerchi sistemazione.
L’anima, il cuore non sono andati via. La mente,
i ragionamenti nei libri, nelle carte.
…………………………..
Hai visto, sono tornata. Più non riparto.
Distendo gli anni, il tempo negli scaffali,
nell’antro dell’armadio. Ascolto il battito
del vento, le sinfonie, il tuo che amavi.
E spolvero che tra qui e l’eterno sia breve spazio.
Sono tornata. Ho solo sbagliato mese, anno.
Per poco i giorni, le ore, la vite ricongiunte.
Per poco le fronti che leggono la ruga,
una sfiorando l’altra, non più alba e tramonto
imparano della vecchiaia l’ansia. Per poco.
Vieni più spesso, nel sogno il passo rallentato,
fruga nel cuore, ch’io non sono poi
così cambiata. Il tempo passato,
torna nella visione a ritmo prolungato.
Libero, liberami dalla nostalgia.
Oppure indicami dov’è il campo,
la strada, la direzione, il tempo, l’ora,
fammi emozione, celebra l’incontro.
Mi siederò nel vento o sarà il canto affranto
di cicale, l’afa che mi darà il segnale.
Aspetta, non andare, devo parlarti,
per le volte nascoste dietro le inutili parole,
la rabbia, la ribellione. Stancami col tuo valzer
di Capo d’anno, che inciampi ancora il piede.
Dammi la rosa, la voce, la mente, il cuore.
………………………………………….
Un po’ alla volta abituo questo guscio,
i suoi pensieri ad essere presente,
a scegliere, ad andare. Ho ritrovato
qualche parola, qualche lampo di te
disceso a consolare, a benedire l’ora.
La traccia, l’orma nel mondo, sul tuo balcone,
nel fiore sbocciato; il seme che torna
nella schermata, sul velluto petalo i colori.
La storia dei mesi adesso prende,
dice il senso delle esistenze allontanate.
Adesso che ti ritrovo sparso nelle foglie,
la tua bellezza nelle cose, nel tempo d’ora,
in questo innamoramento per ogni nuovo giorno,
fa’ che non sia nuovo lutto, il distacco da me,
la morte; il passo sull’asfalto buono anche tremante.
Il volto, la voce, la distanza,
un fiume verso la foce, la speranza,
la mia, quella di rivedere, sentire,
riprendere il discorso abbandonato.
Staccare l’ago dal braccio che ancora preme.
L’odore di liquirizia, il ferro per l’anemia,
— Senti il sapore? — dicevi e lento
iniettavi prima di andare.
Prima di andare hai detto quando tornerò…
tuo padre, il medico, l’amore,
darà alla figlia madre la forza
del medicinale, il coraggio.
Dirà come dividere la sorte e la disgrazia
d’essere nel figlio, d’essere nel padre.
…………………………………………………
L’odore della pioggia,
il cielo bianco di nuvola,
il trapano che trivella,
la vita che prosegue.
Pensare che ho chiesto di morire,
che spesso tutto è insoddisfazione.
Forse dovrei arruolarmi, andare in guerra,
perdermi dentro foreste. Un DNA, il mio, bacato.
Forse non c’entri, padre, con l’essere scombinato
che io sono, né col mio peccato.
Quella prima mattina, quel primo tempo,
quella prima nuvola, quel primo buio
di gennaio, il primo tempo negato.
Il freddo, il freddo così prossimo al saluto,
io ti chiedo trascinami, fuori dalla porta,
scalza, svestita, stanchezza e pianto.
Lontano, lontano sento il lamento del bambino,
la sua fame, la sua culla, il velo che s’impiglia.
Fino alla soglia dell’assoluto nero,
i pensieri bianchi, sgravati dal fastidio,
mi porti e mi fai vedere l’idea ridestata, il grido,
la rinascita del corpo intorpidito,
la verità, la separazione, l’ombra esangue
che con le altre cammina oltre la linea
di me spirito e pelle, assenza che non può seguirti.
Mi tengo aggrappata alla bocca rorida di latte,
le piccole labbra, ventose che succhiano la vita,
l’anima svuotata, appesantita;
mio figlio, la carne generata, il mistero
nell’esistenza andata, di te mai visto,
mai incontrato, udito.
Io nel mio centro vuoto
ricavo un posto per l’eloquio,
in tre a dirci come poteva essere la vita.
…………………………………………
Risistemo le carte, la fatica,
i libri, la mia vita.
Ancora polvere dentro le vetrine,
ancora fili di parole
ancora amore.
Tra noi fiorisce sempre il giorno,
l’eco del canto appoggiato
sulle dita che lucidano,
preparano la scena,
il movimento lento del passato.