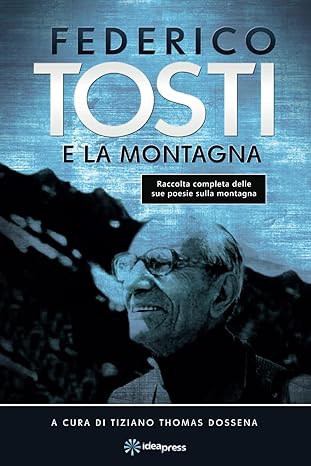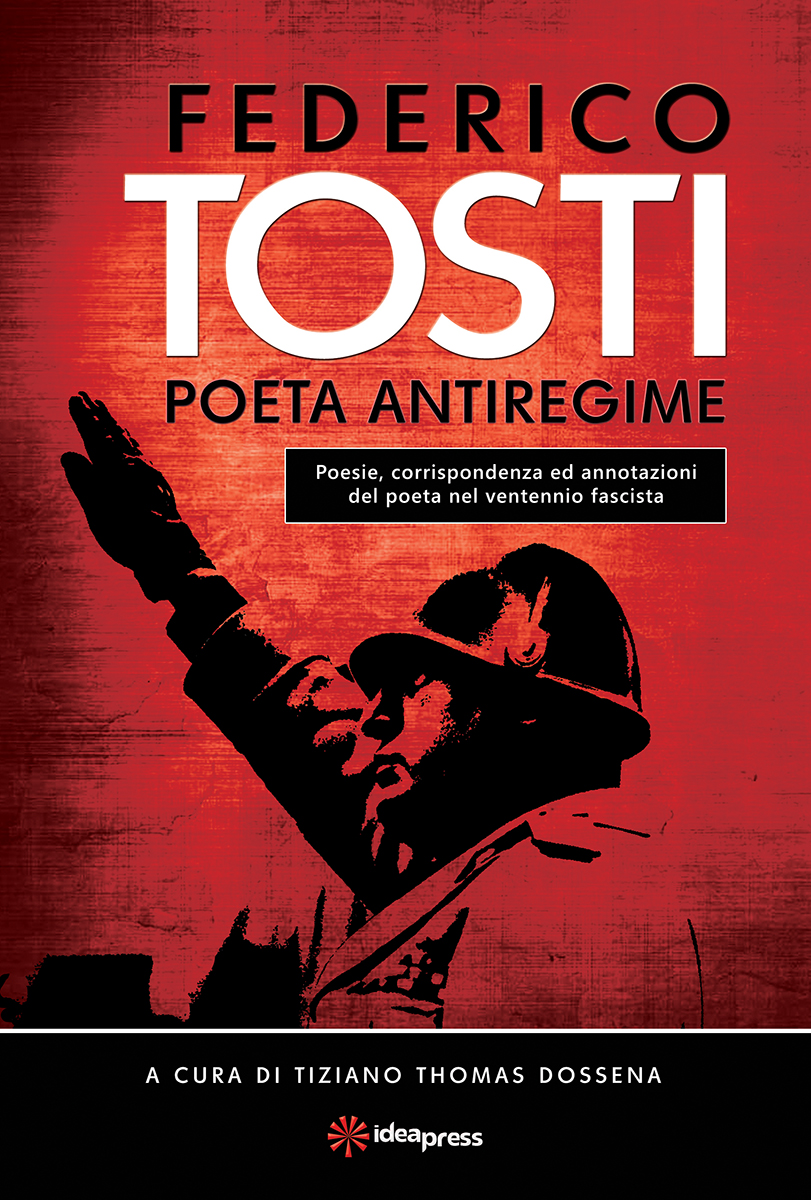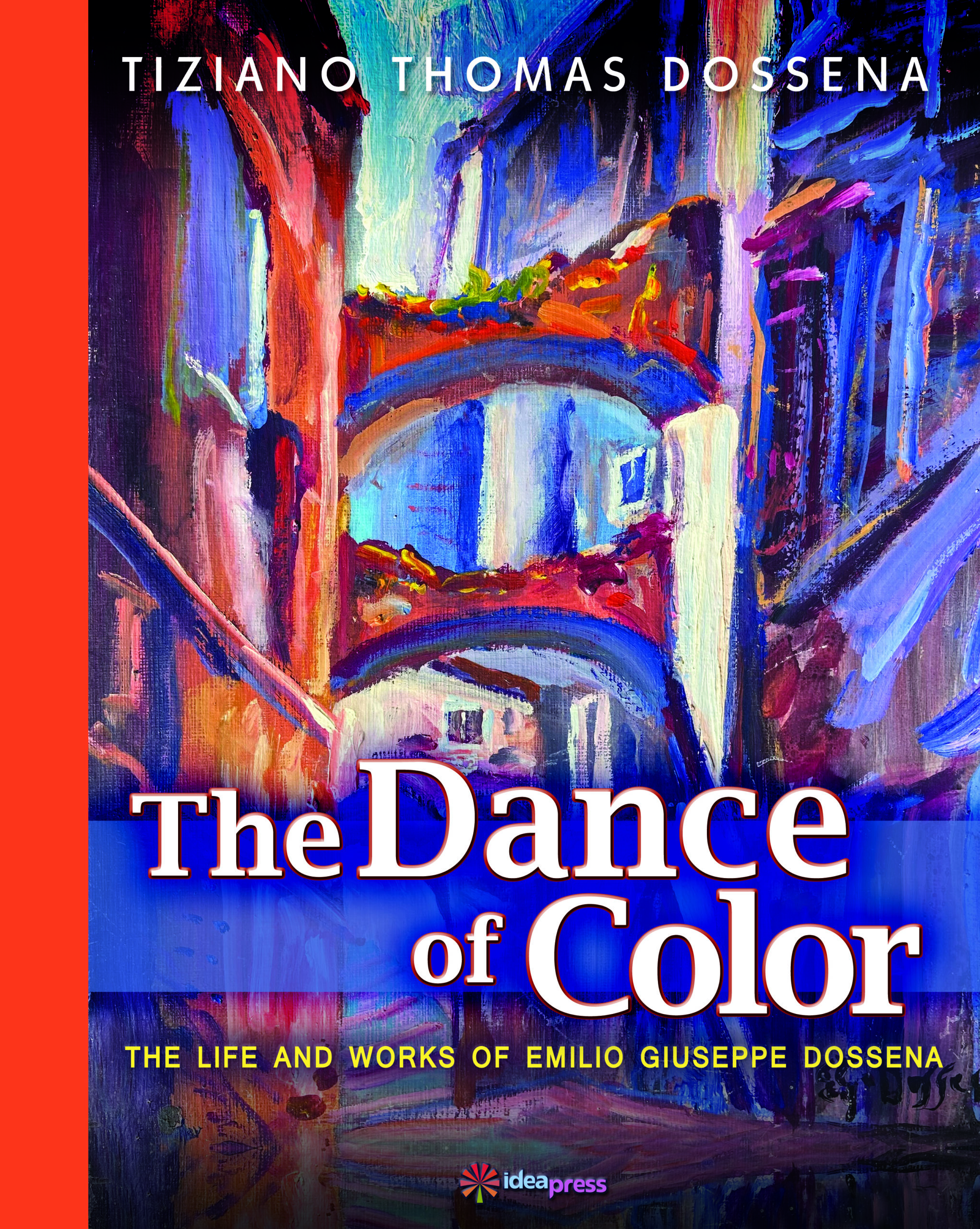Il colore della pelle è uno di quei temi su cui si registra una grande differenza tra la percezione comune e la visione della scienza, con implicazioni politiche, sociali e soprattutto umane importantissime e spesso dolorose, basti pensare alla schiavitù, all’apartheid. Ancora oggi rappresenta uno dei principali, certo non l’unico, elementi di discriminazione delle persone, come se esistesse una relazione causale tra un carattere visibile e le capacità intellettuali o la sensibilità delle persone.
La vista, si sa, ha una grande importanza nella nostra percezione del mondo. Ed è inevitabile che quando ci confrontiamo con una persona all’inizio la nostra attenzione sia attirata dalle caratteristiche fisiche visibili, come il colore dei capelli, degli occhi e della pelle, la statura, la corporatura. Come si verifica in altre specie animali, alcune di queste caratteristiche sono importanti per le nostre scelte protettive e riproduttive, ci permettono di valutare la pericolosità dell’interlocutore oppure lo stato di salute del potenziale partner, con ovvie ricadute sulla possibilità di avere dei figli sani.
Le rappresentazioni di Veneri preistoriche sono una chiara trasposizione artistica di questa valutazione evolutiva nell’arte. Altre caratteristiche fenotipiche ci segnalano se un individuo appartiene o meno al nostro gruppo. Oggi, nel mondo del melting pot e della globalizzazione, con i rapidi e continui scambi, incroci, movimenti di persone, questo tipo di valutazione sta diventando meno importante. Ma per centinaia di migliaia di anni la nostra specie (e prima ancora le varie specie di ominidi che ci hanno preceduto) è vissuta in piccoli gruppi isolati, in competizione tra loro per il cibo. In questo contesto imparare a riconoscere l’estraneo ha avuto senz’altro un valore importante per la sopravvivenza del gruppo a cui si apparteneva.
Questa lotta per la sopravvivenza ha chiaramente plasmato la nostra biologia, molto più di quello che è potuto accadere negli ultimi secoli. Esiste quindi un aspetto naturale nella nostra percezione del colore della pelle. Qualcosa di innato che si può caricare di valori positivi o negativi a secondo del contesto sociale e culturale in cui viviamo. Avevo 4 anni quando a Sanremo, dove abitavo, è arrivata una nave della marina americana. Mi ricordo che davanti a un’edicola ho visto due marinai statunitensi in divisa. Erano le prime due persone di colore che incontravo e sono rimasto a ipnotizzato a fissarli. Uno di loro si è accorto di me, mi ha sorriso e mi ha regalato una monetina di 20 penny che conservo ancora, a distanza di 60 anni.
Dal punto di vista scientifico, il colore della pelle è determinato da fattori genetici e dall’esposizione alla luce solare. La sostanza principale che determina il colore scuro è la melanina, prodotta da specifiche cellule della pelle dette melanociti. Nei “bianchi” (per usare le tradizionali denominazioni) la quantità di melanina è molto inferiore che nei “neri” e il colore è dato dal tessuto connettivo sottostante la pelle e dall’emoglobina che circola nei capillari. Il ruolo della melanina è quello di proteggere le cellule dai danni dovuti dall’irradiazione solare. Esiste una correlazione diretta tra la quantità di raggi Uv che arriva in una particolare regione geografica e la pigmentazione della pelle. In generale, più si è vicino all’equatore, maggiore è l’esposizione ai raggi Uv e più scura è la pelle delle popolazioni indigene. Cosi, se in seguito a migrazione una popolazione si sposta dall’equatore al polo può perdere la pigmentazione originaria: bastano solo 100 generazioni (circa 2.500 anni) per ottenere questo cambiamento macroscopico.
Un altro aspetto interessante è che l’acquisizione di una pigmentazione scura per proteggersi dai raggi del sole si è probabilmente verificata in seguito alla perdita della pelliccia. Le scimmie antropomorfe hanno una pelle chiara sotto il folto pelo, che da un lato protegge efficientemente dagli Uv e dall’altro impedisce una rapida dissipazione del calore. La “scimmia nuda”, l’uomo, ha avuto un grande vantaggio a perdere il pelo, ma ha dovuto acquisire contemporaneamente la capacità di proteggersi dai raggi Uv. Si pensa che questi due fenomeni siano avvenuti circa 1,2 milioni di anni fa.
Ma da cosa protegge la melanina? Sono state avanzate diverse ipotesi. La più accreditata da un punto di vista biochimico è che protegga dalla fotodegradazione del folato in seguito a raggi Uv. Bassi livelli di folato riducono la fertilità maschile e causano difetti nella formazione del tubo neurale (spina bifida), con conseguente morte del neonato. Come è facile capire, entrambi gli effetti rappresentano una forte spinta selettiva a favore di qualsiasi mutazione che riduca la fotodegradazione del folato, che ha un ruolo importante nella termoregolazione, controllando la dilatazione dei capillari cutanei. Infine, la melanina protegge dai danni al Dna indotti dagli Uv agendo come una crema solare naturale.
Circa 50 mila anni fa piccoli gruppi di uomini hanno iniziato a migrare dall’Africa verso altre regioni del mondo, allontanandosi sempre più dall’equatore. Ma esiste un ulteriore fattore che ha favorito l’insorgere della pelle chiara: i raggi Uvb catalizzano la produzione di vitamina D da parte della pelle, una pigmentazione scura ne riduce la produzione, con effetti negativi sulla salute. Grazie agli studi di paleogenetica, oggi sappiamo che i Neanderthal avevano una carnagione chiara in seguito a una mutazione genetica differente da quella che ha permesso ai Cro Magnon provenienti dall’Africa di acquisirla a loro volta. Nelle popolazioni europee moderne diverse mutazioni nei geni MC1R e SLC24A5 hanno contribuito all’evoluzione di una carnagione depigmentata. Nelle popolazioni asiatiche moderne si sono verificati cambiamenti genetici differenti. Le mutazioni che hanno prodotto la depigmentazione della pelle sono insomma varie e si sono verificate più volte nella storia. La tavolozza dei colori della carnagione è cosi vasta che è facile comprendere come questo carattere complesso sia determinato da un grande numero di geni.
Spesso il colore della pelle è stato considerato un marcatore di differenze profonde e di discriminazione. Era diffusa (e purtroppo è ancora così per molti) la convinzione che il colore scuro identifichi popolazioni e persone arretrate, una minore capacità intellettuale e un minor grado evolutivo. Per analogie con le razze animali, il colore della pelle è stato considerato un marcatore per riconoscere le “razze” umane, giustificando in questo modo schiavitù e segregazione, la persecuzione degli ebrei, la discriminazione degli immigranti italiani in America e numerose minoranze etniche, tutti i “diversi”.
Gli studi di Luigi Luca Cavalli-Sforza, che ha fondato l’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia a lui intitolato, hanno dimostrato che dal punto di vista genetico non ha senso parlare di razza umana. Mentre le razze animali selezionale dagli allevatori sono omogenee dal punto di vista genetico, i gruppi etnici umani sono caratterizzati da una notevole variabilità individuale. Più appropriato utilizzare “gruppo etnico”. La differenza genetica tra due individui di pelle bianca può essere superiore alla differenza media tra bianchi e neri. Discriminare le persone sulla base del colore della pelle è solo un modo semplice per nascondere il fatto che stiamo discriminando sulla base di usi, culture, modelli di vita e reddito.

In questi ultimi anni la genetica ci ha permesso di ricostruire la storia dell’umanità e di comprendere l’attuale struttura delle popolazioni umane. Di vedere come le migrazioni abbiano lasciato un segno nelle popolazioni attuali e come la stratificazione genetica si accompagni a quella sociale ed economica. David Reich, in “Who we are and how we got here”, ha riaperto il dibattito sulle razze: è evidente che i marcatori genetici tipici di alcuni gruppi etnici, in alcuni casi, conferiscono una particolare predisposizione verso alcune malattie, ad esempio la malattia di Tay-Sachs, comune tra gli ebrei Ashkenazi. Su questa base c’è chi sostiene che il concetto di razza in campo medico possa essere utile: problemi che la moderna genetica applicata alla medicina sta superando.
Anche i gemelli monozigoti non sono realmente identici. Ogni bambino presenta nel suo genoma almeno 50 differenze rispetto ai proprio genitori. Alcune sono positive, molte sono apparentemente nulle, altre sono dannose. Ma tutte contribuiscono alla variabilità della nostra specie, la premessa per sviluppare la risposta a un ambiente che cambia sotto i nostri occhi e che consente anche la bellezza delle differenze. Come dice Teodosij Grigor’evi Dobzhansky in “Diversità genetica e uguaglianza umana”, ognuno di noi è geneticamente unico. Dobbiamo imparare a vedere nella paletta dei colori della pelle un tesoro di opportunità per la sopravvivenza della specie.
Giuseppe Biamonti