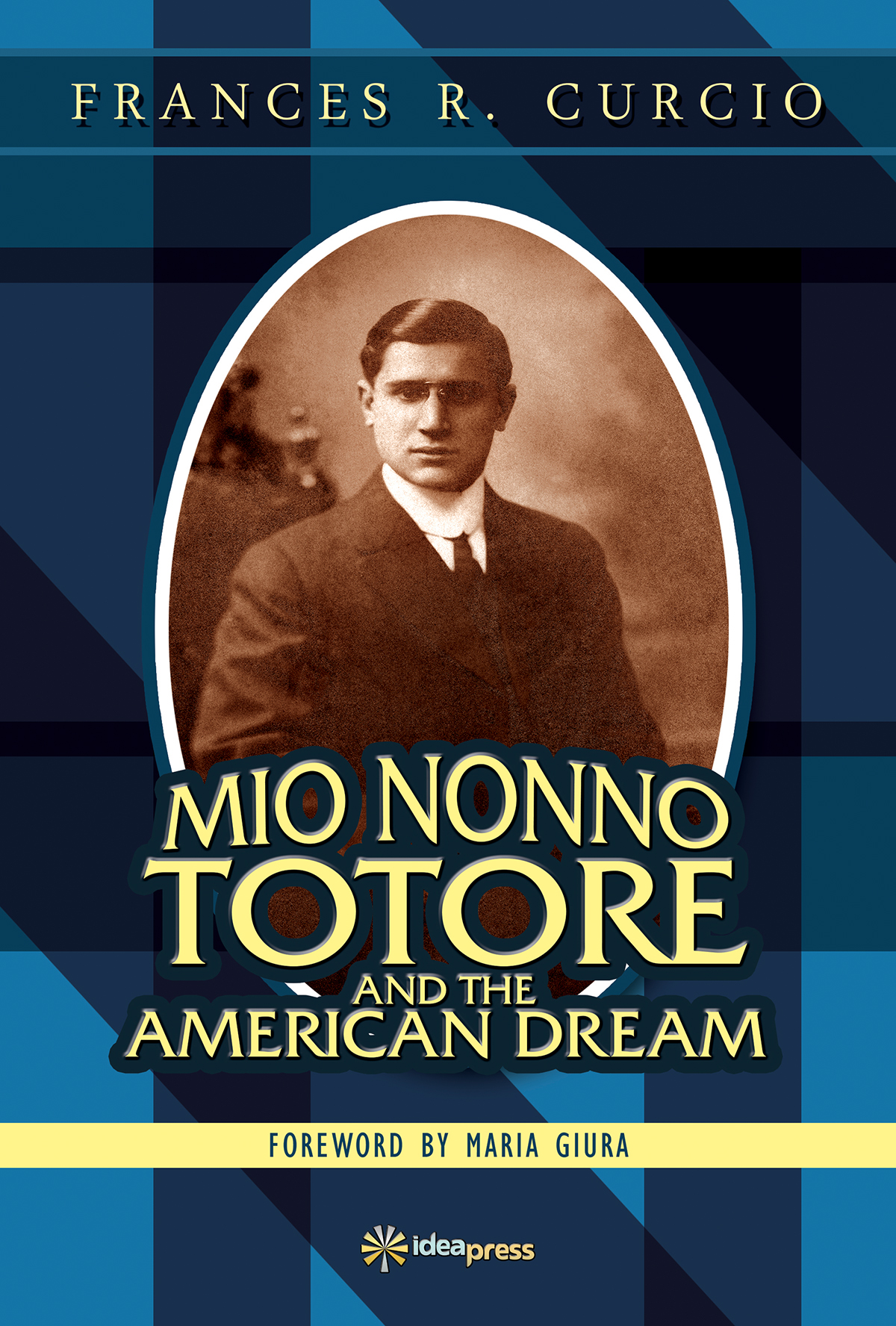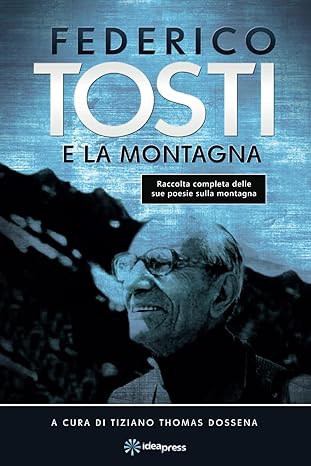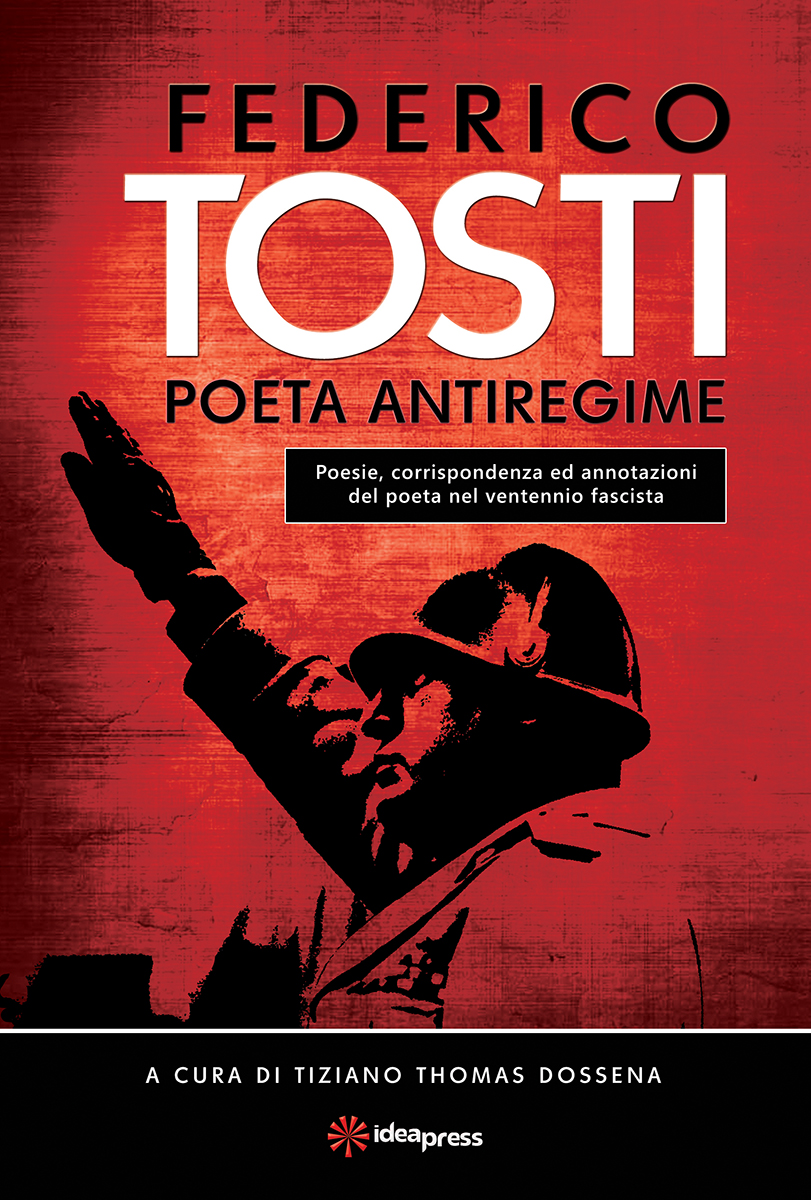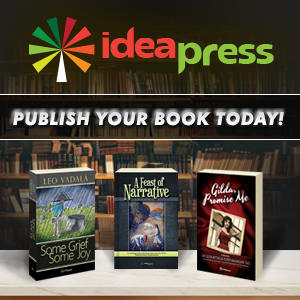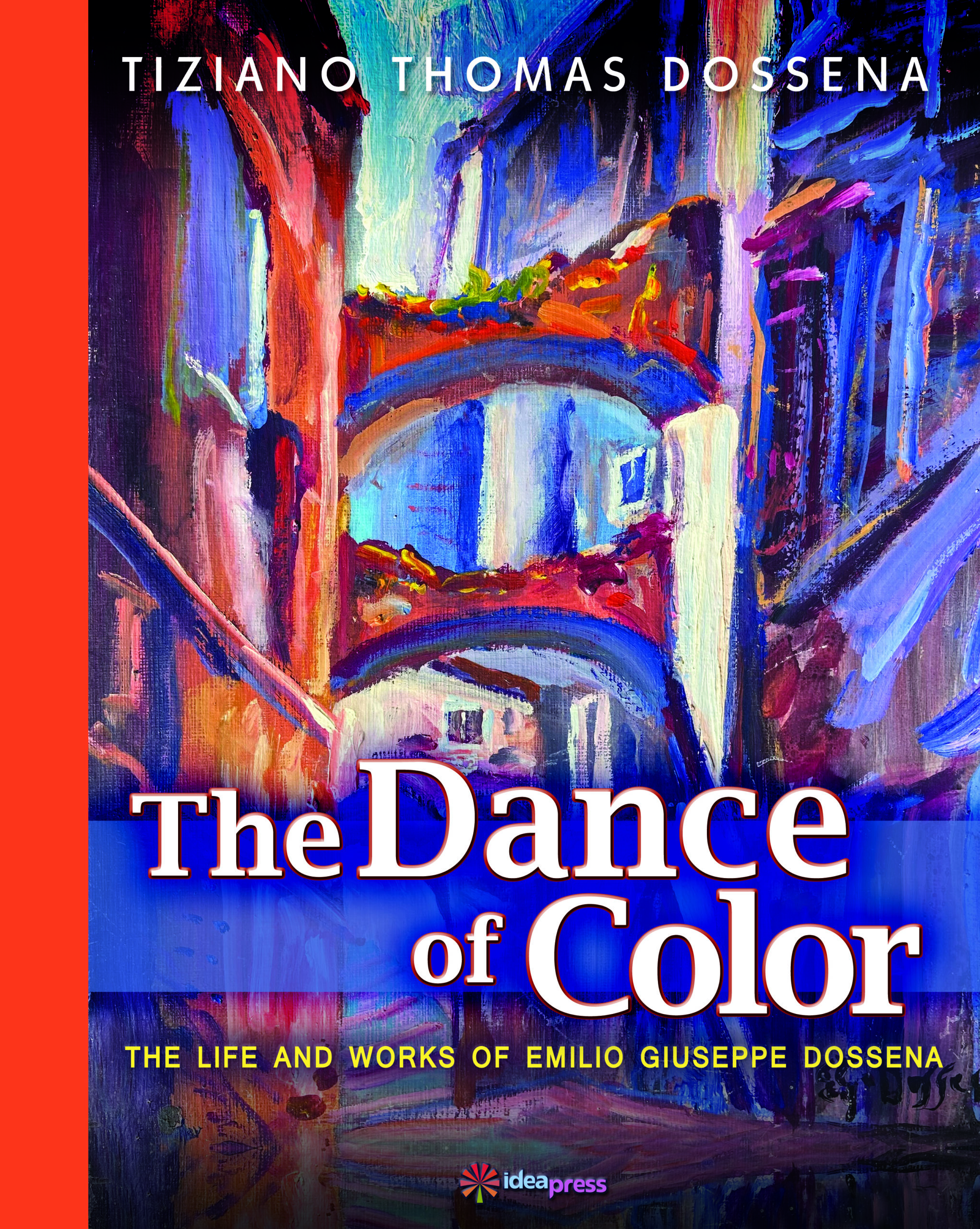Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del celebre inventore Guglielmo Marconi, racconta la storia e le passioni del nonno, dalle ispirazioni giovanili alla poliedrica carriera che ha rivoluzionato le comunicazioni. Parla della nave-laboratorio Elettra, delle amicizie illustri, come Puccini e D’Annunzio, e della visione futuristica del nonno, che ha anticipato tecnologie come il cellulare. Giovanelli Marconi, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Meier, riflette anche sulla sua personale eredità culturale e sul suo distacco dalla tecnologia moderna, in linea con l’etica del nonno
Guglielmo Giovanelli Marconi è appassionato di Storia, docente universitario e nipote del celebre inventore Guglielmo Marconi. Laurea in economia e commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, tenente in congedo nell’Esercito italiano, è autore dal 2007 al 2012 del programma televisivo di Storia “Il cenacolo delle Vie della Tradizione” su Rete Oro. Ha collaborato alle riviste “Le Vie della Tradizione”, “Hera” e “Historia” e dal 2019 è presidente della sezione Lazio dell’Istituto italiano dei castelli. Attualmente, ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università popolare Meier di Milano.
Nell’intervista, Giovanelli Marconi condivide aneddoti e riflessioni sulla vita e le innovazioni di suo nonno, mettendo in luce la poliedrica personalità dello scienziato e le sue numerose amicizie illustri, come quelle con Puccini e D’Annunzio. Inoltre, Giovanelli Marconi riflette sull’eredità culturale ricevuta e sul suo distacco dalla tecnologia moderna, in linea con l’etica del nonno, che concepiva le sue invenzioni e la tecnologia essenzialmente come strumenti per il bene comune.
Come nasce la passione per la scienza in Marconi?
Ho conosciuto mio nonno non direttamente, essendo nato tre decenni dopo la sua scomparsa, nel ’37. Tuttavia, ho avuto la fortuna di vivere in casa di mia nonna, Maria Cristina Bezzi Scali, che ha sposato Guglielmo Marconi, restando con noi parecchi decenni ancora dopo la morte del marito. È colei che mi ha passato le memorie, le testimonianze della persona, dell’uomo, del marito, dello scienziato e di tutte le sue, diciamo, polivalenze. Fu durante una gita, questo me lo raccontava sempre, che lui ebbe l’ispirazione. Si trovava con i genitori al monastero di Oropa, vicino Biella, in Piemonte. In quella occasione, all’età di 15 anni, forse anche 14, iniziò a riflettere sui fulmini e il suono dei lampi, sulla differenza tra luce e suono, a capire che bisognava vedere cose che l’occhio non era in grado di vedere. Questo lo spinse ad abbonarsi a un mensile dell’epoca, “L’elettricità”, in cui i teorici della comunicazione senza fili esprimevano le loro idee. Fu attratto dalle teorie di due professori, in particolare, Maxwell e Hertz, che furono i primi grandi teorici della possibilità delle onde elettriche invisibili all’occhio umano.
Una passione sconfinata, senza dubbio, ma avrà avuto altri interessi?
Certo, aveva un carattere poliedrico, interdisciplinare, che lo portò a interessarsi anche di altro, soprattutto di musica e letteratura. Era un melomane, infatti quando comprò lo yacht-laboratorio che chiamò Elettra, la prima cosa che fece fu acquistare un pianoforte. Amava molto Chopin e Beethoven e la sera si dilettava a suonare per la famiglia, per gli ospiti. Non è un caso che tra le sue amicizie ce ne fossero alcune molto importanti nel campo musicale. Conosceva molto bene Giacomo Puccini che aveva la villa a Torre del lago in Versilia. Uno dei porti dove Elettra ancorava, oltre a quello di Genova che era il principale, dove c’era lo Yacht Club Reale, era proprio quello di Viareggio. Per cui, quando con lo yacht si fermava lì, trascorreva le serate in compagnia dell’artista. Mia nonna mi raccontava anche di un’altra grande amicizia che aveva stretto con il tenore Enrico Caruso. Quando, per i suoi esperimenti, si recava a New York, spesso andava a trovarlo in teatro e, prima dell’esibizione, pare che Marconi, nel backstage, cercasse di spronarlo e incoraggiarlo. Poi, quando lasciò gli Stati Uniti per arruolarsi come volontario nella Prima guerra mondiale, conobbe e divenne amico di Gabriele D’Annunzio. E quando ottenne l’incarico di presiedere la Reale Accademia d’Italia, nel 1930, oggi i Lincei, fece entrare D’Annunzio e anche Pirandello ed Enrico Fermi con i quali pure, nel frattempo, era entrato in ottimi rapporti.
Lei, dati i suoi interessi, ha ereditato soprattutto questi altri aspetti del carattere del nonno?
Sì, senza dubbio. Sono un docente di storia. Quando Marconi con l’Elettra girava per il mondo – attraversò 87 volte l’Atlantico solo per andare negli Stati Uniti – aveva un atlante storico-politico a bordo, ben curato, ci teneva così a informarsi della situazione del Paese che stava per visitare, dal punto di vista storico, politico e sociale. Non dimentichiamo che era, tra l’altro, presidente della Enciclopedia Italiana Treccani, era un pozzo di informazioni anche sulle situazioni politico-sociali estere.
Torniamo sulla nave. Perché la scelse?
Non fu un divertimento mondano. La comprò per usarla davvero come laboratorio galleggiante. Lontano da occhi indiscreti, gli garantiva un clima ambientale ideale per gli esperimenti. Aveva dei nemici, senza dubbio. Uno tra i principali era la tedesca Telefunken e poi anche le altre società di cavi sottomarini. Consideriamo che fino alla invenzione della radio, il monopolio delle comunicazioni dipendeva dai cavi sottomarini elettrici, con cui si comunicava tramite il telegrafo a fili. Per cui la sua invenzione rappresentava un grave danno economico. Cercarono sempre di fargli causa, fu una lotta spietata. La nave Elettra gli risolveva in parte questi problemi.

Un ricordo di Marconi papà che le ha lasciato la figlia Elettra?
Mia madre mi ha sempre detto che, quando era piccola, parlo di cinque, sei, sette anni, Marconi non voleva mai essere disturbato durante il lavoro nella cabina radio. Però, poi, la faceva entrare, le spiegava tutto in un linguaggio semplice. La trattava molto bene, insomma. Diceva sempre che la vera comandante della Elettra, era Elettra. La fece partecipare, insieme a mia nonna, Maria Cristina, a degli esperimenti compiuti sulle coste liguri intorno al ’33, ’34, ’35, riguardanti la cosiddetta navigazione cieca, che possiamo considerare come l’antenata dei radar. Chiedeva loro di mettere delle lenzuola davanti alla cabina di comando, per oscurare la vista e quindi faceva passare la nave attraverso due boe, usando quel sistema per captare gli ostacoli.
Ha sviluppato diverse tecnologie importanti, a parte la telegrafia senza fili, se ne ricorda qualcun’altra?
Una è l’antenna parabolica, antenata del satellite, che costruì sulla costa ligure. Quando il team di Neil Armstrong venne a Roma negli anni ’70, poco dopo il famoso allunaggio, mia nonna lo incontrò a Villa Taverna e l’astronauta americano le svelò che non sarebbero mai partiti per quel viaggio spaziale senza le scoperte di Marconi. Non da ultimo, un’altra invenzione importante figlia in qualche modo della radio, che aveva previsto pochi mesi prima di morire, è il cellulare. Durante un convegno americano in cui si riunivano istituti ingegneristici e tecnologici, tenne un discorso in cui disse che un giorno ognuno avrebbe avuto un apparecchio tascabile con cui poter comunicare con le famiglie, con l’avvocato, con i posti di lavoro, etc. Un ricordo divertente, se vuole, è legato a Martin Cooper, che era a conoscenza del discorso fatto da mio nonno in Usa. Cooper è l’inventore del primo cellulare “a scarpa”. Nel 2013 venne a Bologna per ritirare un premio, occasione in cui confessò, molto onestamente – il che non è scontato per un americano – di ritenersi un continuatore di Marconi. Riconosceva nel cellulare una discendenza diretta del wireless, della comunicazione senza fili.
Un aneddoto legato a suo nonno cui è particolarmente affezionato?
Quando fu invitato alla inaugurazione del Titanic, a cui non partecipò, pur trovandosi a New York, perché doveva sviluppare la filiale della compagnia Marconi inglese in America. Seppe subito della tragedia e andò al porto di New York per assistere all’arrivo dei superstiti, dei naufraghi che arrivarono lì e quando capirono che era Marconi, alla cui invenzione dovevano la vita, si verificò una scena di affettuosa isteria, di entusiasmo forte, comprensibile, gli strapparono i bottoni della giacca, la polizia dovette intervenire per tenerli a bada. A mia nonna avrebbe raccontato in seguito che la ricompensa più bella della sua vita la ebbe in quel preciso momento.
Le è piaciuta la serie Rai in onda di recente?
Sì, molto. Ovviamente è una fiction, quindi contiene anche parti di fantasia. Le scene che sono piaciute molto, sia a me che a mia madre, sono quelle girate a bordo della nave. Sono molto verosimili, anche con il capo marinaio che veniva con le anguille, il pesce fresco e in cambio Marconi gli faceva sentire alla radio con le cuffie la musica straniera. Si tratta di episodi veri, ripresi dal libro scritto da nonna: “Mio marito Guglielmo”. Bella e anche questa veritiera la scena finale, col discorso che lui fa all’Accademia d’Italia, in cui spiega che il vero e unico scopo delle sue invenzioni era la salvezza dell’umanità e non la distruzione di essa. Quindi la comunicazione wireless vista come pace, come dialogo tra i continenti, per l’avvicinamento dei popoli, il superamento delle divisioni, è tutto vero. Il resto è parte, ovviamente, del racconto di fantasia, non è un documentario storico, ma nel complesso è un buon lavoro.
Lei oggi dirige il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università Meier di Milano, ma che rapporto ha con la tecnologia, i social media?
È abbastanza distaccato, ho un cellulare vecchio stampo che ha solo sms, non ha internet e nonostante tutto, ci convivo benissimo. Non sono sui social. Credo che anche Marconi non avrebbe avuto entusiasmo per questi media. Lui concepiva la scienza con una certa etica, le invenzioni devono essere impiegate per il bene comune. Ecco, i social li avrebbe forse ammessi solo in funzione umanitaria.
[L’Almanacco della Scienza N.6, 2024]