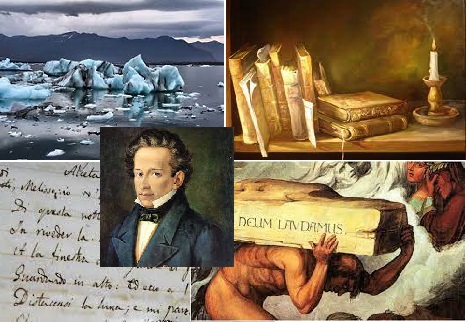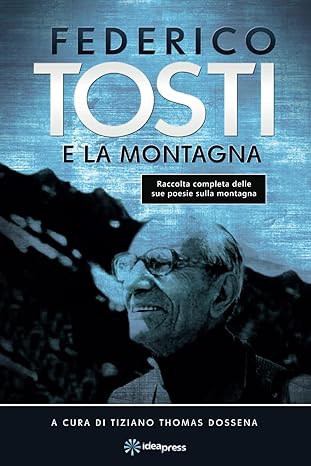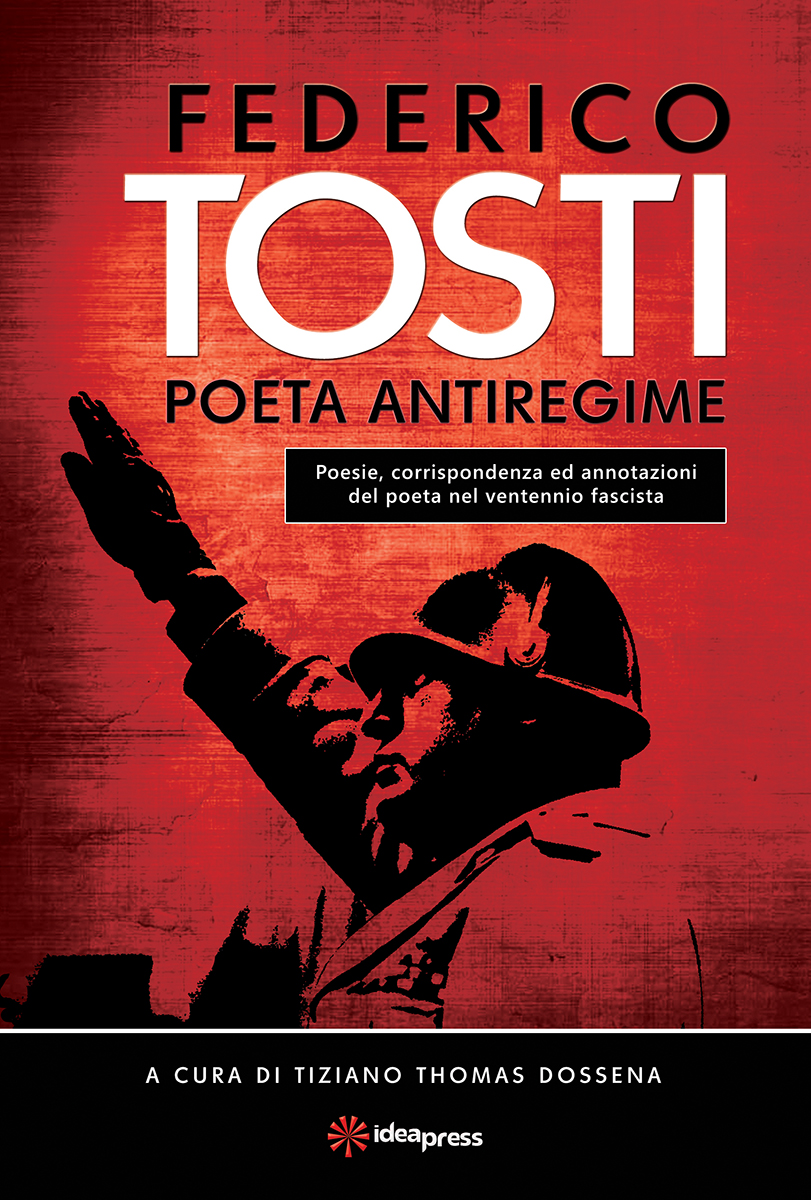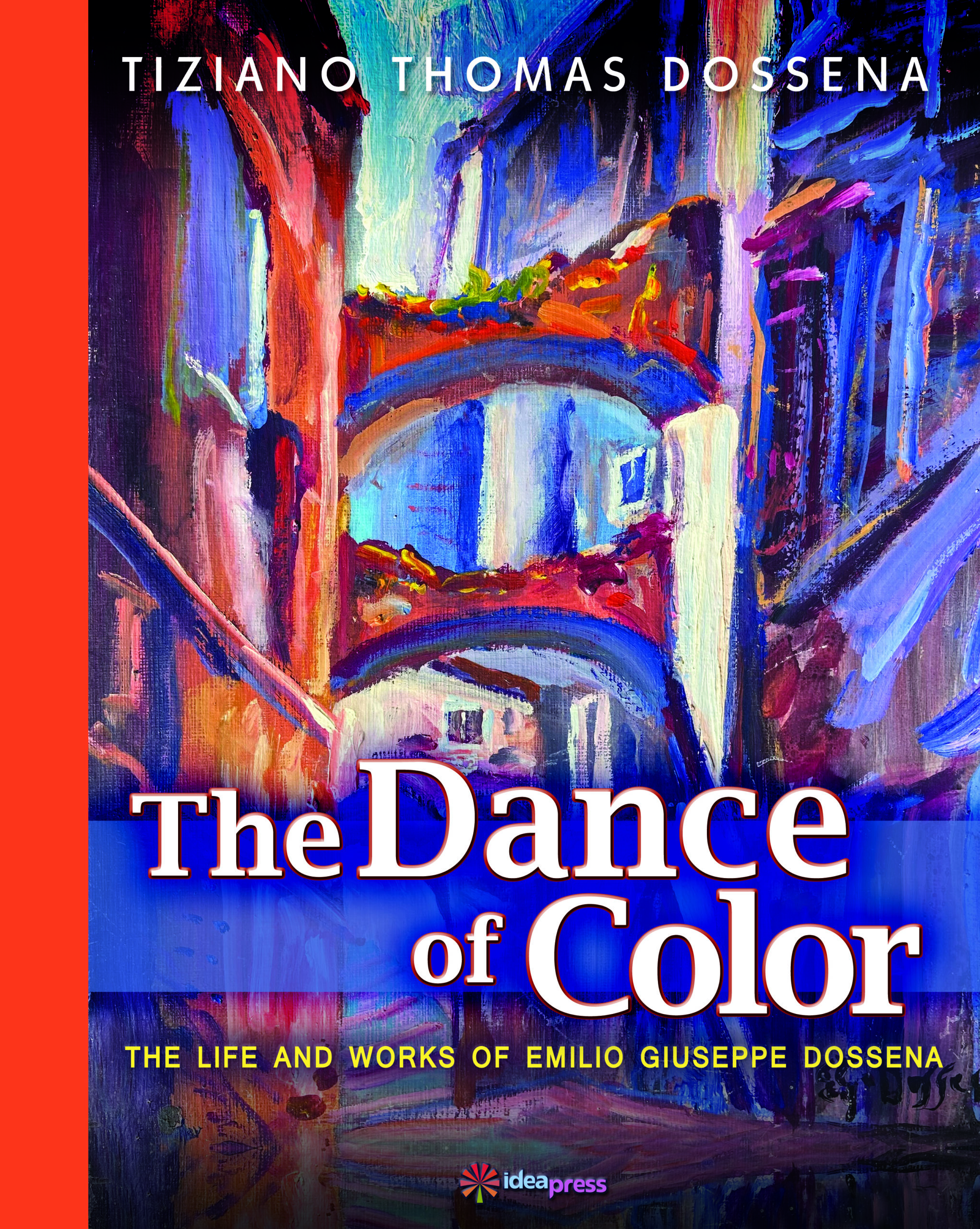di Marina Agostinacchio

La terra: la casa che ci accoglie, ci nutre, la madre terra, l’involucro sicuro, accogliente, caldo d’amore. Queste le immagini che mi hanno accompagnata fino a quando non scoprii il Leopardi delle Operette morali.
“Ma ora che ei sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla…” dirà il Folletto, in uno dei saggi dialoghi (nello specifico si tratta del Dialogo di un folletto e di uno gnomo, composto tra il 2 e il 6 marzo 1824), costruiti dal poeta recanatese in risposta allo Gnomo, sostenendo la ritrovata autonomia del pianeta Terra, dopo la scomparsa della vita umana, scioccamente resa tale dall’uomo stesso.
Ma come ha potuto autodistruggersi l’umanità nella inventio leopardiana? Bene, l’uomo ha peccato di superbia e, credendo di essere autosufficiente, ha rotto l’equilibrio che teneva in mano l’intero pianeta, attraverso la catena degli elementi indispensabili a sostenere il sistema aria, terra, acqua.

Nel testo cui accennavo, un folletto e uno gnomo irridono la credenza dell’uomo che il mondo sia fatto per potere essere usato ed abusato per il proprio godimento e i propri interessi. Per i due dialoganti, il mondo, invece, potrebbe esistere e sopravviverebbe ugualmente senza la presenza dell’uomo.
In un altro dialogo, (Dialogo tra un cavallo ed un bue), l’uomo viene definito “una scimia, una razza di animali… che si trovano più, che la razza è perduta, ma i miei nonni ne raccontano gran cose che le hanno sentite dai loro vecchi… delle bestie maledette… Ciascuno badava ai fatti suoi!. oziosi ecc. indolenti ecc… Da principio non era così. Poi gli uomini trovarono altre arti (la politica moderna) gl’ingrassavano gli accarezzavano e poi davano loro sulla testa ecc. ecc. In proposito degli animali perduti. Anche gli uomini s’erano mutati assai ed erano quasi altri animali da quelli di prima che s’erano perduti. Perché da principio erano molto più forti e grandi e corputi e di più lunga vita che dopo, che a forza di vizi s’indebolirono e impiccolirono, come anche le razze nostre (de’ cavalli, ed anche de’ buoi) s’indebolivano e imbastardivano tra le loro mani, e per averne delle belle e forti le andavano a pigliar nelle selve ecc. e così le piante. Da secoli immemorabili non avevano altro che dire, oh che mondo, oh che mondo, e tutti, padri e figli, giovani e vecchi dicevano sempre la stessa cosa, e il mondo non migliorava mai…”

Insomma, nell’umanità in genere, Giacomo Leopardi, già ai suoi tempi, intravedeva i sintomi della catastrofe finale. E la colpa l’attribuiva all’eccesso di razionalismo dell’uomo a cui aveva portato l’illuminismo, a una volontà di sondare, con la forza della pura ragione, tutto ciò che capitava sotto agli occhi.
Leopardi non propone una scelta di campo tesa a valorizzare l’ignoranza, quanto, invece, parlarci del danno provocato dall’abuso di una misura della ragione a proprio uso e consumo.
L’esplosione all’interno di un rapporto armonico tra uomo e natura, “la violenta modificazione del paesaggio, l’alterazione degli equilibri nella biosfera, la consumazione cinica delle risorse, l’asservimento e lo sterminio del mondo animale, insomma le amare testimonianze di un’apocalisse sempre più all’orizzonte”, (come scrive il giornalista Antonio Prete a proposito del libro di Niccolò Scaffai — Einaudi editore — libro che ha per titolo Racconti del pianeta Terra), paiono quasi avverare quanto con occhio clinico il recanatese abbia presagito, nei suoi anni, attraverso l’osservazione dei comportamenti umani.

Se pensiamo come per Leopardi la parte di antico, di fanciullo, di istintivo buono sia stata sommersa dall’estrema razionalità dell’uomo, in forma di calcolo egoistico, possiamo dedurre anche come per il poeta il super-ego apotrocentrico abbia prodotto un vuoto.
Infatti, l’uomo di siffatta immagine non sa misurarsi che con sé stesso, poiché è in sé stesso che pone una smisurata fiducia nel rapporto con l’alterità, sia essa umana o cosmologica.
Leopardi prende atto del fatto che la terra madre, ospitante, accogliente è stata ingannata dalla specie umana che ha logorato nel tempo e senza sosta tutto ciò che le era stato offerto. Tradimento di noi umani a un Eden donato, distrutto! E a vantaggio di chi o di cosa? Leopardi ci dice a favore di una tecnica che avrebbe liberato l’uomo stesso da un patto di armonia e di equilibrio con la terra.
Quanto può constatare lo scrittore recanatese sono le conseguenze di scelte ed atti incoscienti, miopi, irrimediabili. Su tutto egli vede dolore, dolore degli esseri creaturali.
Leopardi ci parla quindi di una nostalgia che solo attraverso la scelta e il recupero del linguaggio andato smarrito, può restituire bellezza e senso all’uomo.

In polemica con la lingua prodotta dalla cultura illuminista dei Francesi che Leopardi definisce “geometrica” (nella poetica di Leopardi: i ‘termini’ indicano in modo univoco, palese, esplicito un oggetto), lo scrittore oppone le ‘parole’ che incanalano “attorno all’oggetto un insieme vago di senso” chiamato da lui stesso «idee accessorie». Sono proprio queste sfumature della lingua italiana, intesa come ricchezza, abbondanza di significanti determinati dai suffissi, che rendono poetico un linguaggio.
Vago e indefinito, prodotti dalla scelta delle parole, sono due assiomi del pensiero poetico leopardiano.

Di essi si può trovare riscontro nello Zibaldone (diario personale di 4526 pagine che raccoglie appunti, riflessioni e aforismi, scritti tra il luglio/agosto 1817 e il dicembre 18329 e in periodi diversi). Vago e indefinito possono risuonare solo a condizione di un ritorno del passato nel ricordo. Lì, in quell’eterno presente, la mente dell’uomo ricrea in forma di idealizzazione quanto di anche sfumato e impreciso rende vividi la rimembranza.
Parole come notte, oscurità, lontano, profondo, antico, ultima volta, futuro, passato, mortale, eterno, lungo, tanto, danno un senso di vastità, un significato indefinito e impreciso, non certo individuabili come errore o difetto, ma come “la ricchezza della lingua italiana che nel corso del tempo ha portato alla stratificazione che si è accumulata in determinati termini”.

Amare, quindi, sembra il suggerimento al nostro pensiero e alle nostre azioni, prendersi cura di quel che rimane ed è ancora salvabile, coltivare la bellezza, l’armonia, del pianeta o di quel che resta della sua distruzione, anche partendo da un’operazione estetica, come sembra indicarci Giacomo Leopardi nelle sue riflessioni filosofiche dello Zibaldone, tra l’accusatorio e la prospettiva liberatoria in esso sottesa.