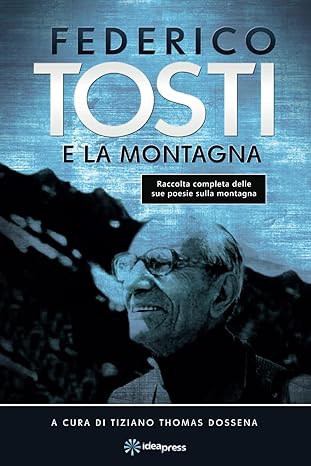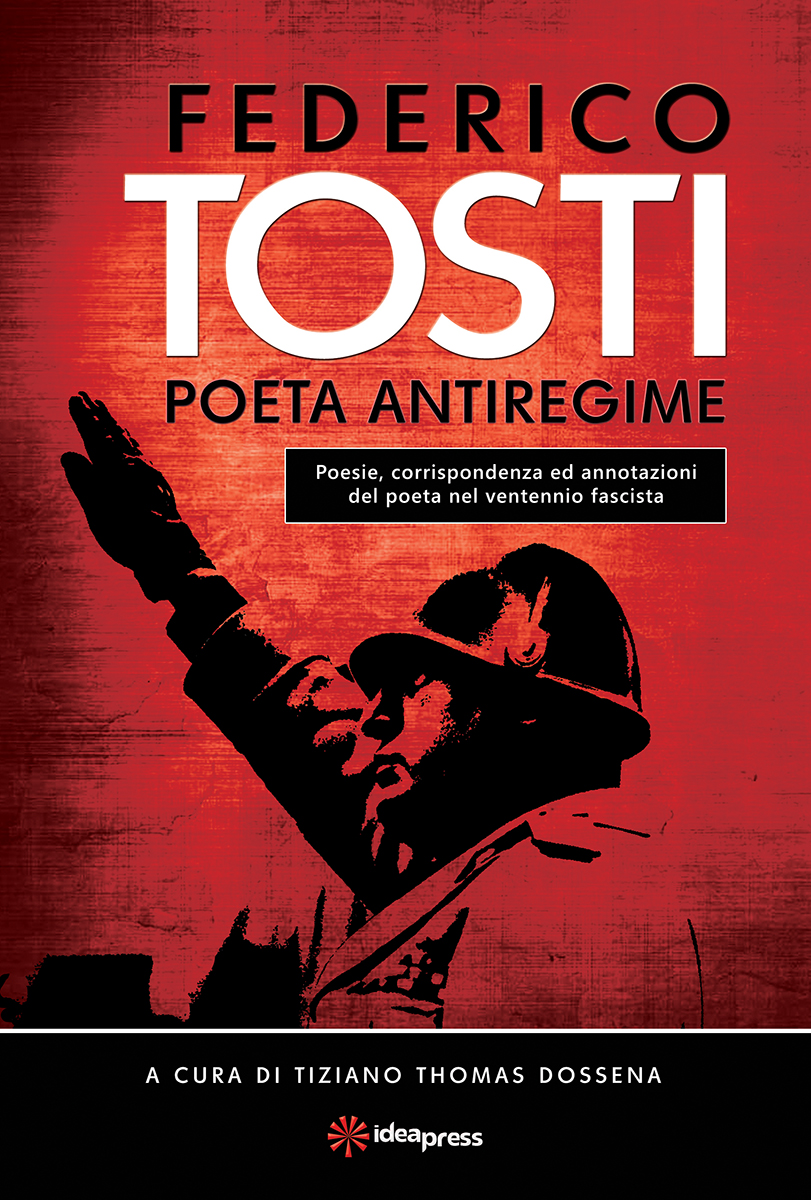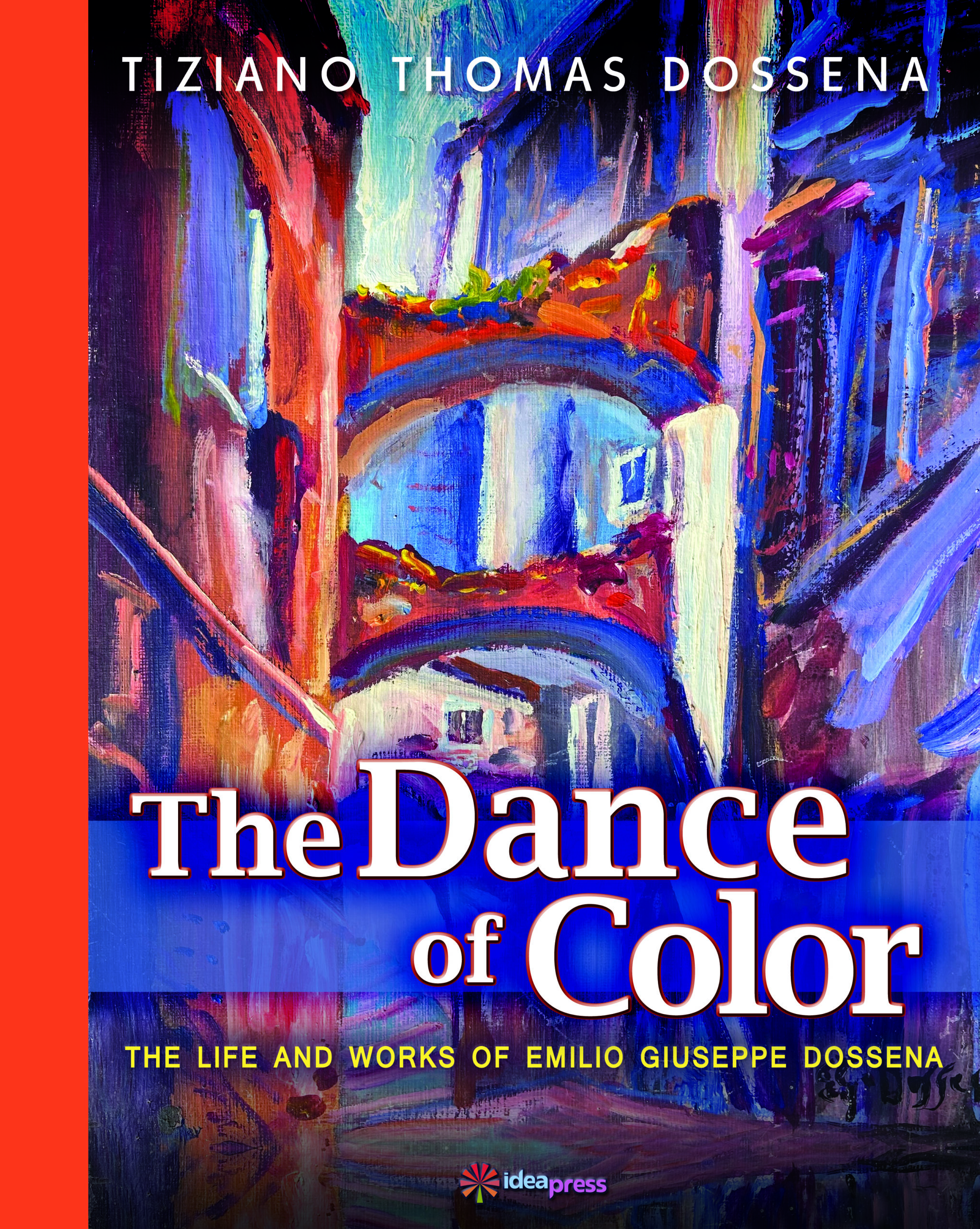Di Alberto Guasco
A spiegare l’origine storica e l’adattamento linguistico subito dall’espressione “è tutto un ambaradan” è Alberto Guasco dell’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche. Che ricorda come a utilizzarla per primi furono gli stessi soldati che parteciparono nel 1936 alla battaglia da cui essa deriva
È noto che la storia, tra le altre cose, è anche un immenso ventre capace di partorire espressioni e modi di dire destinati a entrare nel linguaggio comune. Si pensi, ad esempio, a quelli nati a seguito di eventi militari di particolare peso, e in modo speciale a due espressioni – differenti nella forma ma non nella sostanza – quali “è una Waterloo” o “è una Caporetto”.
Se certe volte l’ingresso della storia dentro la lingua parlata e scritta è più immediato, o più ufficiale, in altre occasioni è invece più tortuoso, o più nascosto. È questo il caso dell’espressione “fare un ambaradan” (o in casi ben più rari, “fine dell’ambaradan”) – ovvero: fare una enorme confusione – mutuata da quella pagina nera, tanto tragica quanto rimossa, che è la nostra storia coloniale: l’aggressione militare dell’Italia fascista all’Etiopia del 1935-1936.
L’Amba Aradam, cioè “l’altura mozzata” Aradam, è uno tra gli altopiani montuosi d’Etiopia, situato nella regione settentrionale del Tigrè, a circa 50 chilometri dalla capitale Addis Abeba. È per l’appunto qui che, tra il 10 e il 19 febbraio 1936 – durante la battaglia dell’Amba Aradam – le truppe italiane agli ordini del generale Pietro Badoglio infliggono una dura sconfitta all’esercito etiope, mettendolo in fuga.
Descritta così, la battaglia sembra piuttosto asettica. Al contrario, analizzata più in dettaglio, lascia intravedere aspetti di confusione totale. Da un lato l’esercito italiano fronteggia quello fedele al negus, l’imperatore Haile Selassiè, dall’altro diverse tribù mercenarie etiopi rimbalzano dall’una all’altra armata combattendo per il miglior offerente, cambiando continuamente bandiera e rendendo difficile comprendere davvero chi sono gli alleati e chi i nemici. Con buona pace di Indro Montanelli, come la storiografia ha da tempo accertato senza ombra di dubbio, a questo carnaio si mescola l’uso indiscriminato di armi chimiche. Per quanto vietate dalle convenzioni internazionali, la nostra aviazione e le nostre truppe di terra fanno largamente uso di iprite, fosgene e arsina, inondando le truppe etiopi, i civili, il bestiame e i campi, distruggendo ogni forma di vita – e dunque di possibile resistenza – davanti a sé.

Al termine del massacro, e della fuga delle truppe etiopi, è pur vero che, come telegrafa lo stesso Badoglio a Mussolini, “il tricolore sventola sull’Amba Aradam” e che per la conquista di Addis Abeba è solo questione di tempo. Ma è anche vero che, una volta riapparso (per appena cinque anni) l’impero “sui colli fatali di Roma” – è parola del Duce – e una volta ritornati in patria i nostri soldati portano con loro l’immagine di quel caos, e cominciano a utilizzare l’espressione Amba Aradam come sinonimo d’una situazione disordinata, caotica, incomprensibile. E in una cultura ancora largamente orale, che sopravvive al fascismo e transita direttamente nel secondo dopoguerra, lo fanno storpiando l’espressione originaria: con una crasi, da due parole ne germina una sola, più musicale; e sempre per ragioni armoniche la m finale si trasforma in n. È nato il termine “ambaradan”, un mezzo scioglilingua, una parola vagamente esotica, un invito a nozze per i motti e le canzonette dell’avanspettacolo di quei tempi.
È questo il modo in cui: prima, un luogo diventa una battaglia; poi, una battaglia diventa una battaglia particolarmente caotica; e, infine, una battaglia particolarmente caotica diventa un modo di definire il caos. Sdrucciolata dal campo di battaglia a quello del linguaggio, e lì definitivamente rimasta, l’Amba Aradam è invece direttamente sopravvissuta in toponomastica. Ovvero, vie e viali dell’Amba Aradam si ritrovano ancora a Padova, a Roma (dov’è particolarmente nota per ospitare la sede dell’Inps) e in altre località ancora, a testimonianza ormai semi-invisibile che quello degli “italiani brava gente” fu solo e soltanto un mito. Come per altri casi analoghi – si pensi ai molti via Arbe (cioè Rab, l’isola croata sede del peggior campo di detenzione costruito dagli italiani nel corso della Seconda guerra mondiale) disseminati nelle nostre città – si tratta d’una piccola spia d’una memoria sempre più lontana, che occorrerebbe conoscere e saper pensare.
[Almanacco della Scienza N. 1, gennaio 2023]