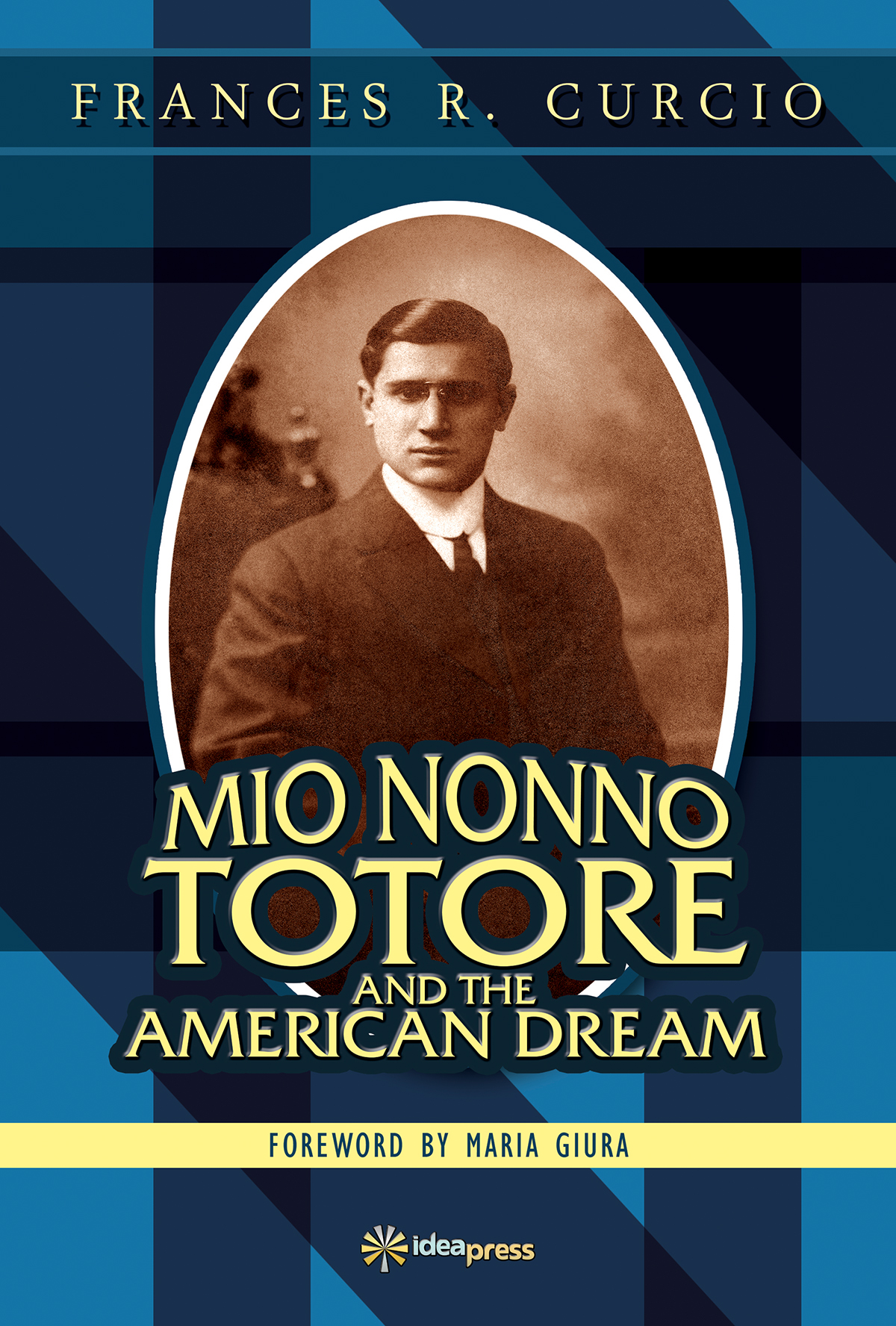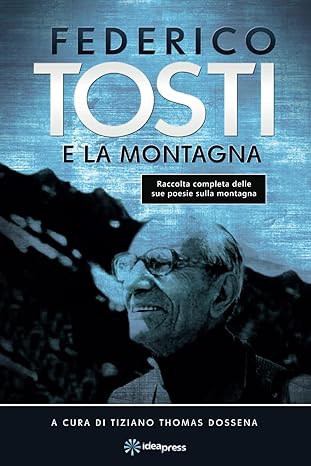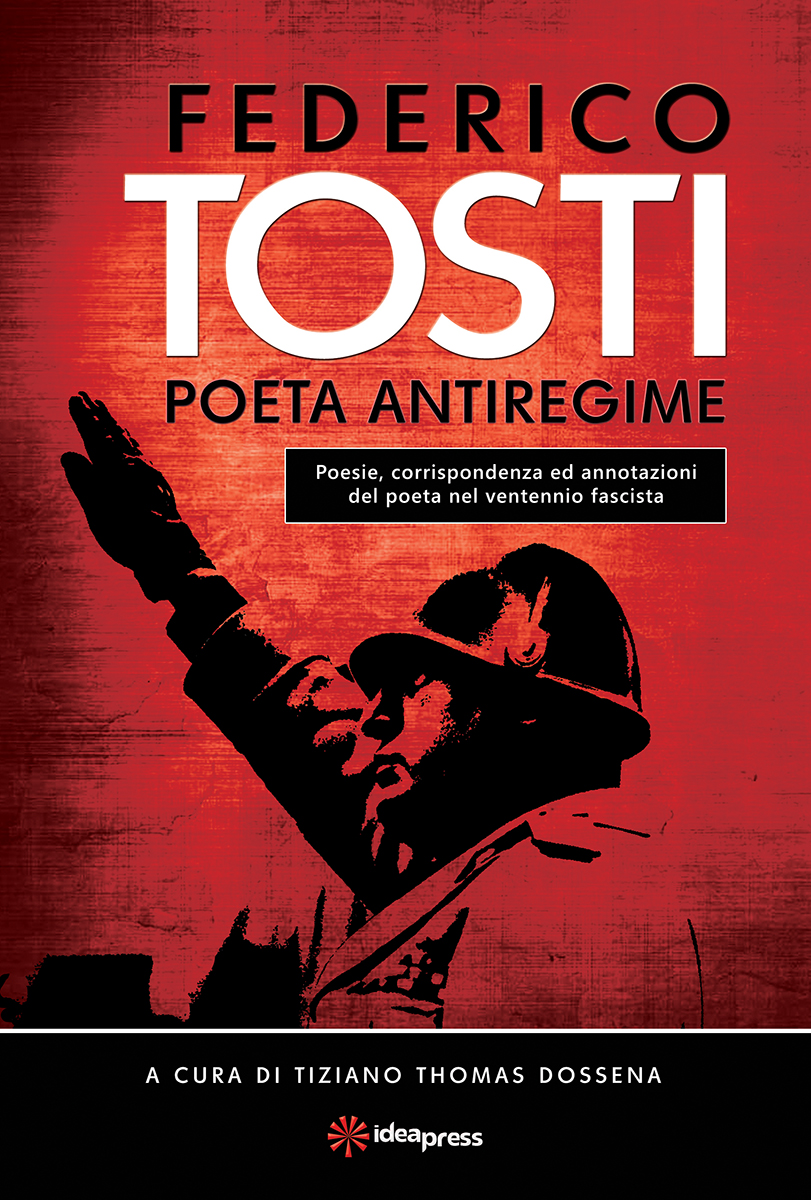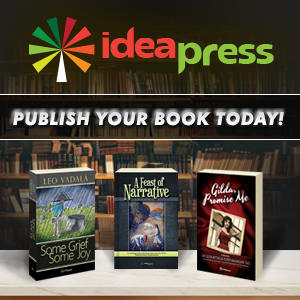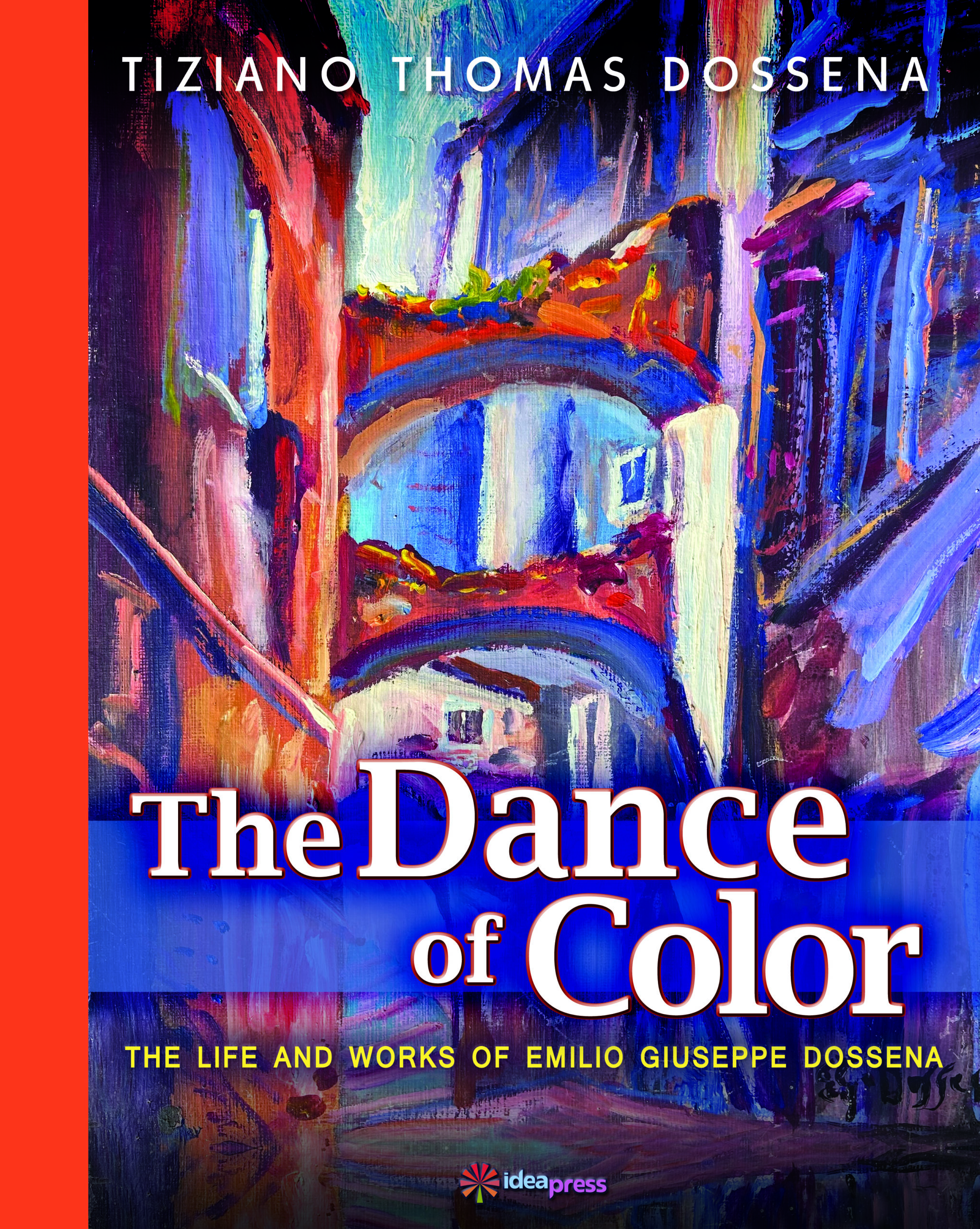Per questi animali, l’attrazione è alla base di comportamenti come la riproduzione, la difesa del territorio e la formazione di colonie. Gli insetti utilizzano un’ampia gamma di segnali per comunicare e richiamarsi a vicenda, sfruttando suoni, luci, odori e persino vibrazioni, spesso non percepibili dai nostri sensi. Discutiamo di questi aspetti con Diego Fontaneto dell’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr
Nel mondo degli insetti, la comunicazione e l’attrazione avviene attraverso una varietà di segnali sensoriali. Studiare questi meccanismi in laboratorio richiede quindi ingegno e tecniche specifiche. “Le attrazioni nel mondo degli insetti sono varie: usano tutti i possibili sensi per comunicare e, quindi, se li si vuole studiare in laboratorio si deve inventare qualche modo per misurare quello che percepiscono. La cosa non è troppo difficile se ci si focalizza sui segnali che percepiamo anche noi: tutti conosciamo il frinire delle cicale e dei grilli e lo zillare delle cavallette. Se questi insetti comunicano e si attraggono con i suoni, possiamo percepire anche noi i loro suoni e riprodurli in laboratorio per condurre esperimenti”, evidenzia Diego Fontaneto dell’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Cnr. “In modo simile possiamo inventarci esperimenti con segnali visivi, ad esempio per studiare come le lucciole si attraggano con i loro segnali luminosi emessi al buio. Diventa tutto molto più difficile se i suoni emessi o i colori usati sono fuori da quelli che possiamo percepire noi. E diviene ancora più complicato inventare in laboratorio esperimenti di attrazione che coinvolgano segnali tattili e odorosi, segnali che noi non siamo in grado di capire e nemmeno percepire. Per i segnali odorosi, anche una volta individuati i composti chimici usati, non è detto che li si riesca a riprodurre per gli esperimenti”.
L’attrazione tra insetti spesso è mediata da segnali chimici come i feromoni, fenomeno biologico di grande interesse applicativo. Studiata inizialmente in ambito entomologico per comprenderne il comportamento riproduttivo e sociale, questa forma di attrazione è oggi sfruttata in numerosi settori; in agricoltura, ad esempio, i feromoni vengono impiegati in trappole ecologiche per il monitoraggio o il controllo delle popolazioni di insetti dannosi, riducendo l’uso di pesticidi. Anche in ambito sanitario, nella lotta contro vettori di malattie, e nella conservazione ambientale, per lo studio e il censimento delle specie, questi meccanismi di attrazione offrono soluzioni sostenibili ed efficaci. Il loro utilizzo dimostra come una comprensione profonda del comportamento naturale possa tradursi in tecnologie innovative e a basso impatto ambientale. “I segnali chimici legati all’attrazione tra sessi diversi della stessa specie di insetti, ovvero i feromoni sessuali, vengono usati per attirare insetti di specie di interesse agrario. L’attrazione può essere usata per tenere gli insetti dannosi in agricoltura lontano dalle zone da proteggere, ma anche e soprattutto come esca per eliminare questi insetti e rimuoverli. Esistono anche feromoni di allarme o composti chimici repellenti, che possono essere usati, al contrario, non per attirare gli insetti, ma per tenerli lontano. Un esempio di questo tipo può essere la citronella per tenere lontano le zanzare”, chiarisce l’esperto.

Molti insetti sono attratti dai fiori perché sanno che nei fiori ci sono sostanze di cui si nutrono. Il nettare che si trova nei fiori è proprio uno dei meccanismi “inventati” dalle piante per attirare insetti sui fiori. I fiori usano quindi ogni stratagemma, come profumi, colori e forme differenti. “Il profumo del nettare attira gli insetti diventando una sorgente di cibo: anche noi sfruttiamo questa sorgente alimentare approfittando delle api che raccolgono il nettare e lo condensano nel miele. Esistono fiori che attirano molti tipi di insetti, ma alcuni attirano solo determinate specie, ad esempio mettendo il nettare in fondo a lunghe corolle, che solo insetti con una lingua molto lunga possono visitare. Mentre alcune piante disperdono i gameti maschili al vento per raggiungere i gameti femminili di un’altra pianta e far avvenire la fecondazione, tutte le piante con fiori usano gli insetti per raccogliere il polline e trasportarlo per far avvenire l’impollinazione”, spiega Fontaneto.
Ci sono degli insetti impollinatori molto efficaci, praticamente tutti gli insetti che vediamo sui fiori sono buoni impollinatori, a parte qualche raro caso di insetto che sottrae il nettare evitando il contatto con il polline. “È difficile stilare una graduatoria dei migliori insetti impollinatori: visto che ogni specie di pianta usa strategie diverse per attirare insetti diversi, dovremmo stilare una graduatoria per ogni specie di pianta. Ad esempio, anche le api e i bombi, usati in agricoltura come efficienti impollinatori ‘artificiali’ di frutta e verdura, sono inutili per le orchidee, che usano solo una determinata specie di insetto che non siano api o bombi. Tra gli insetti pronubi, che trasportano il polline da un fiore all’altro permettendo l’impollinazione e la conseguente formazione del frutto, sono buoni impollinatori molti imenotteri (api e bombi), ditteri (sirfidi), lepidotteri (farfalle e falene), e coleotteri, ma non solo”, continua il ricercatore del Cnr-Irsa.
Alcuni insetti, come le zanzare, sono particolarmente attratti dall’uomo a causa di una combinazione di segnali chimici e fisici che gli esseri umani emettono naturalmente. Tra i principali fattori che guidano questa attrazione ci sono l’anidride carbonica espirata, il calore corporeo, l’umidità della pelle e peculiari composti chimici presenti nel sudore o nel microbiota cutaneo. Questi segnali sensoriali vengono percepiti dagli insetti attraverso recettori altamente specializzati, che li aiutano a localizzare le loro “prede” anche a molta distanza. Comprendere questi meccanismi è fondamentale non solo per approfondire la conoscenza del comportamento degli insetti, ma anche per sviluppare strategie più efficaci di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da vettori come le zanzare. “Gli insetti sono attirati da noi perché hanno bisogno di noi: le femmine fecondate di alcune specie di zanzara hanno bisogno di un pasto di sangue per la maturazione delle loro uova. Hanno bisogno di trovare in fretta e in modo efficace la sorgente da cui trarre il sangue, per cui usano ogni segnale possibile per individuarci. Visto che siamo animali a sangue caldo, tra i segnali più facili che segnalano la nostra presenza ci sono il calore e la produzione di anidride carbonica, in aggiunta al profumo irresistibile che emaniamo. Ognuno di noi ha un profumo leggermente diverso: tutti ci siamo accorti di come alcune persone effettivamente ‘piacciano’ di più alle zanzare di altre, oppure di come in alcuni giorni noi stessi attiriamo di più o di meno le zanzare, a seconda di quello che abbiamo mangiato. Sembra che mangiare banane aumenti la produzione di forme volatili derivate dall’acido lattico, che attirano le zanzare”, afferma Fontaneto.
Gli insetti che si nutrono di sangue, detti ematofagi, come zanzare, pulci e pappataci, possono trasmettere malattie infettive. Quando pungono un ospite per prelevarne il sangue, essi possono iniettare nel corpo sostanze che impediscono la coagulazione e riducono il dolore della puntura. Se l’insetto è infetto da un microrganismo patogeno come virus, batteri, protozoi o vermi, può trasferirlo all’ospite attraverso la saliva. Questo processo, noto come trasmissione vettoriale, è alla base della diffusione di malattie come la malaria, la dengue e la febbre gialla. “Purtroppo, la puntura di un insetto come la zanzara apre una porta verso il nostro interno e molti microorganismi sono in grado di sfruttare le zanzare per entrare nel nostro corpo. Un esempio famoso è la malaria, malattia causata da un gruppo di protozoi parassiti chiamati plasmodi, che riescono a entrare nel nostro sangue con la puntura di alcune specie di zanzara del genere Anopheles. In realtà, per il plasmodio della malaria, noi siamo solo un mezzo di trasporto verso altre zanzare: la riproduzione sessuale dei plasmodi avviene solo nelle zanzare, che sono il vero ospite definitivo, mentre noi rappresentiamo solo ospiti intermedi, di passaggio. I protozoi come i plasmodi della malaria non sono gli unici organismi nocivi che possono essere trasmessi a noi dalle zanzare: molti virus di cui si sente parlare ogni tanto, come dengue, febbre gialla, zika, chikungunya e febbre del Nilo sono trasmessi dalle zanzare. Un altro parassita di cui si sente spesso parlare in connessione con le zanzare è la filaria: un verme nematode che viene trasmesso a cani e gatti dalle zanzare. Almeno per questo parassita, in Italia, noi siamo inutili: la filaria non riesce a svilupparsi bene nel nostro corpo, malgrado le zanzare lo trasmettano anche a noi. Nelle zone tropicali, esistono però altre filarie che causano l’elefantiasi, trasmessa da zanzare, e la cecità fluviale, trasmessa da simulidi, piccoli moscerini che vivono in acque correnti. Oltre a zanzare e simulidi, anche i pappataci possono trasmettere malattie, come le encefaliti causate dal virus toscana, presente in Italia centrale e in altre zone mediterranee”, conclude il ricercatore.