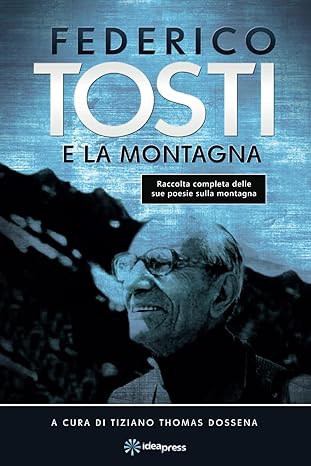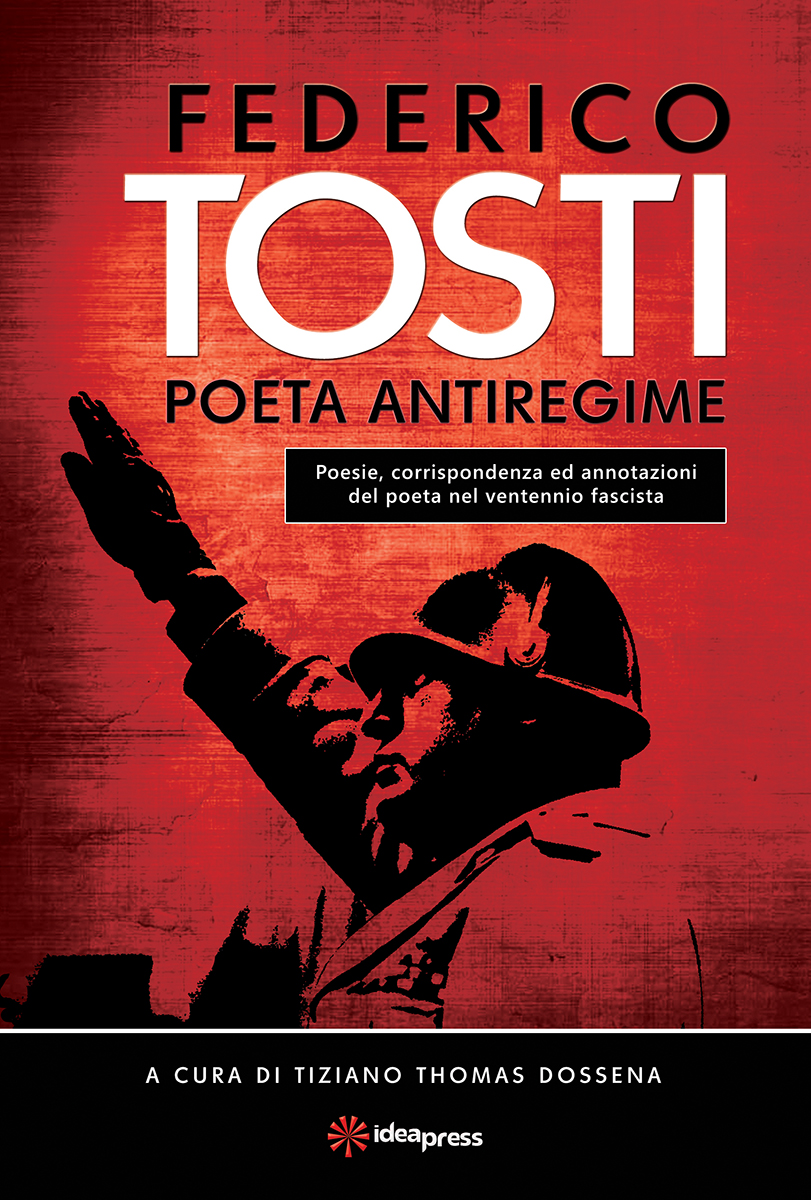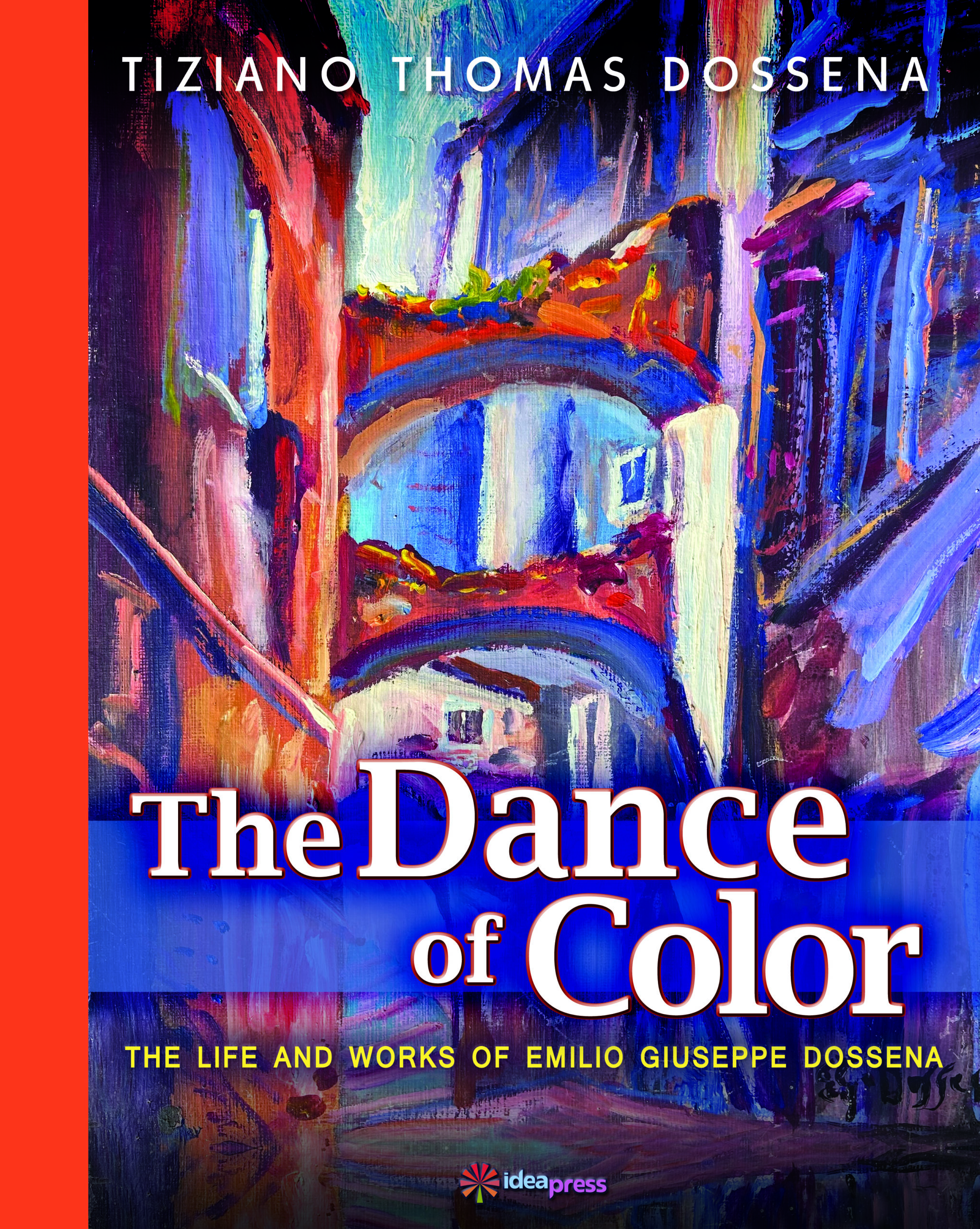Ogni volta che abbiamo a che fare con qualcosa di diverso mettiamo in atto meccanismi e sistemi di protezione che, inconsciamente, pensiamo possano tutelarci da ciò che non riconosciamo. Ansia, paura, incertezza, dubbio, curiosità sono i sentimenti che animano l’uomo quando si trova a dover gestire qualcosa che rientra nella sfera di ciò che è differente dal proprio modo di essere o di pensare, come spiega Antonio Tintori dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr
La paura del “diverso” è profondamente radicata nell’essere umano, la diversità rappresenta infatti un’incognita che crea un divario tra reale e ideale, come spiega Antonio Tintori, sociologo dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Irpps) del Consiglio nazionale delle ricerche. “L’ideale non sempre coincide col reale. Ideale è ciò che guida le azioni, che produce significati, spiega aspirazioni e rende reali le distanze nella diversità sociale. L’ideale misura della distanza tra individui e gruppi, che sottintende gerarchizzazioni dello spazio sociale, gioca un ruolo primario nei rapporti intersoggettivi, nell’interpretazione della diversità, nel benessere individuale e collettivo. Per effetto della pigrizia del nostro sistema cognitivo, che tende a semplificare la realtà e la complessità relazionale in rigide e scarne categorie di pensiero, connotiamo le persone mediante un’attribuzione aprioristica di caratteristiche socio-psicologiche che codificano aspettative verso sé stessi e gli altri, spesso addirittura in modo auto-limitante”.
Nell’essere umano è presente la tendenza a riconoscersi prevalentemente in gruppi composti da simili. Perché questo avviene? “Il senso di appartenenza che ci offre il riconoscimento in gruppi composti da simili è specularmente propedeutico all’identificazione dei ‘diversi’, che spesso coincidono con i nemici, socialmente costruiti. Diversi ci ritroviamo allora per origini, abilità, orientamenti, età, credenze, status sociale. In questo modo su ognuno di noi grava sempre un’etichetta. Solo se siamo catalogati come parte di uno specifico gruppo sociale possiamo infatti misurare la distanza da altri gruppi e individui, cosa che ci viene molto spontanea essendo poco inclini alla reciprocità e a ideali di uguaglianza. La distanza sociale, però, anche quando è solo ideale, produce conseguenze reali nella pratica dell’agire umano. Tali sono ad esempio quelle prodotte dagli stereotipi di genere che con la socializzazione primaria (in famiglia) acquisiamo nei primi anni di vita”, continua il ricercatore. “Nella maggior parte dei casi non è vero che ognuno di noi vive in modo dissimile la diversità sociale. Piuttosto, aderendo per imitazione e omologazione a distorti ideali precocemente assunti e rispecchianti la struttura e la distribuzione del potere socio-economico, contribuiamo inconsapevolmente ad alimentare asimmetrie già presenti, discriminazioni, segregazioni, violenze. Quelle che sovente acriticamente replichiamo sono logiche di in-group/out-group”.

La diffidenza nei confronti della diversità spesso genera stereotipi che creano distanza tra individui e gruppi sociali. “Riprodotti di generazione in generazione, gli stereotipi sono frutto di una costruzione umana: idee che nulla hanno a che vedere con le predisposizioni biologiche cosiddette ‘naturali’ che usano a giustificazione gerarchie sociali derivanti dai ruoli che stabiliscono gli individui debbano assumere nella vita reale sulla base della loro appartenenza. I livelli di adesione agli stereotipi sociali, a partire da quelli di genere, sono tutt’oggi impressionanti. Non è sufficiente, quindi, parlare degli stereotipi, ricordarli in prestabiliti momenti dell’anno e rievocarli di fronte a tragici eventi, bisogna sviluppare la capacità di vederli tutti i giorni, di ammetterne l’esistenza, dal momento che ancora non li riconosciamo nemmeno quando ne subiamo gli effetti in prima persona”, precisa l’esperto.
Nascere uomo o donna è la prima e più importante diversità che sperimentiamo ed è tutt’altro che indifferente essere l’uno o l’altra ai fini dei concetti che la cultura ci riserva. “La socializzazione binaria implica precise assunzioni di ruoli sociali (di genere) in età adulta, che nel preservare lo status quo presuppongono preminenza maschile e subalternità femminile. Identificare il proprio ruolo sociale sulla base del sesso conduce molte donne a una forma di auto-segregazione, cosiddetta orizzontale, che le subordina a mansioni stereotipate, ovvero ad aderire alla tipizzazione di genere della formazione e delle professioni, lasciando ai maschi ruoli chiave e di comando”, aggiunge Tintori.
Sempre in termini di asimmetrie, molte altre distanze vengono percepite verso chi è diverso da sé, per il colore della pelle, l’orientamento sessuale, il credo religioso o anche per differenze culturali o economiche. “Anche in questi casi non è insolito porre dei limiti verso sé stessi per via dell’autopercezione del proprio status. Nascere poveri e in un ambiente socialmente degradato, ad esempio, fa certamente la differenza, ma stabilire che il proprio destino non possa che aprioristicamente implicare la conservazione dello status ascrittivo la sancisce”, conclude il ricercatore.