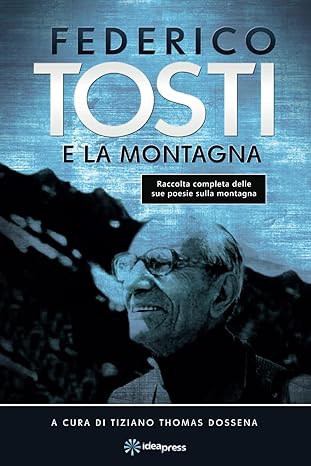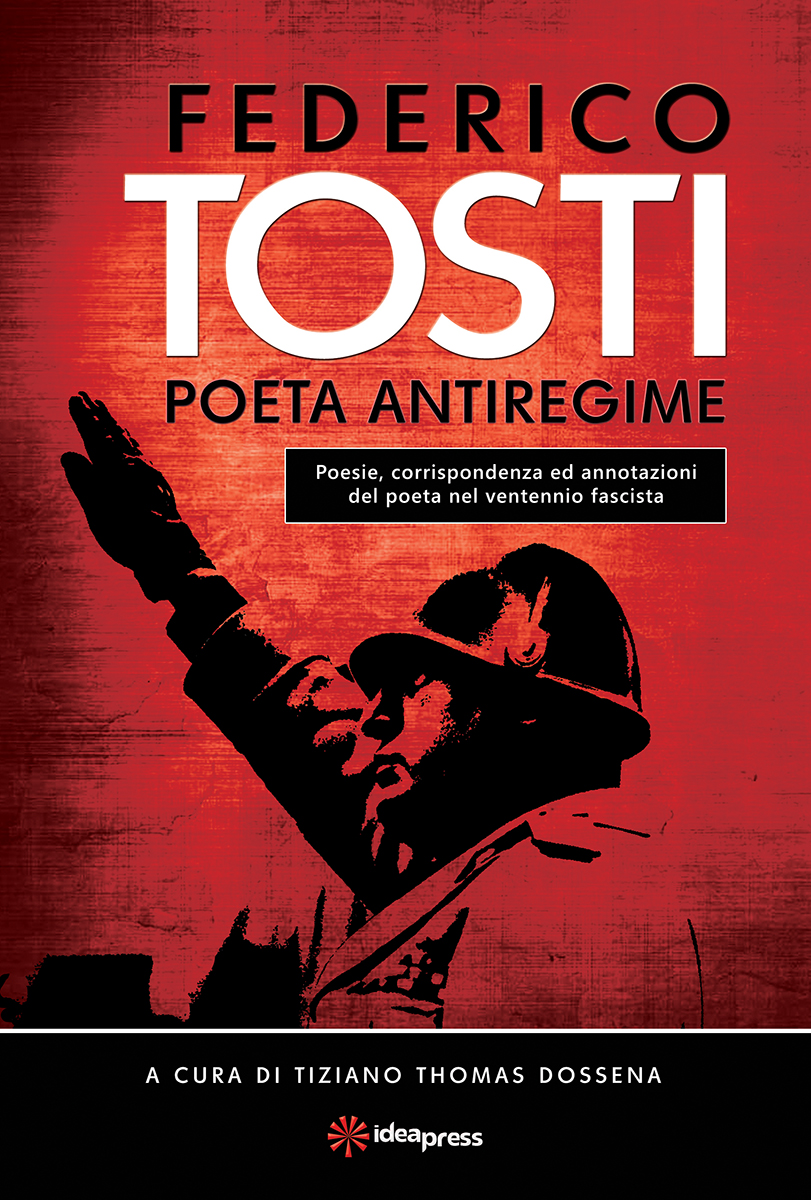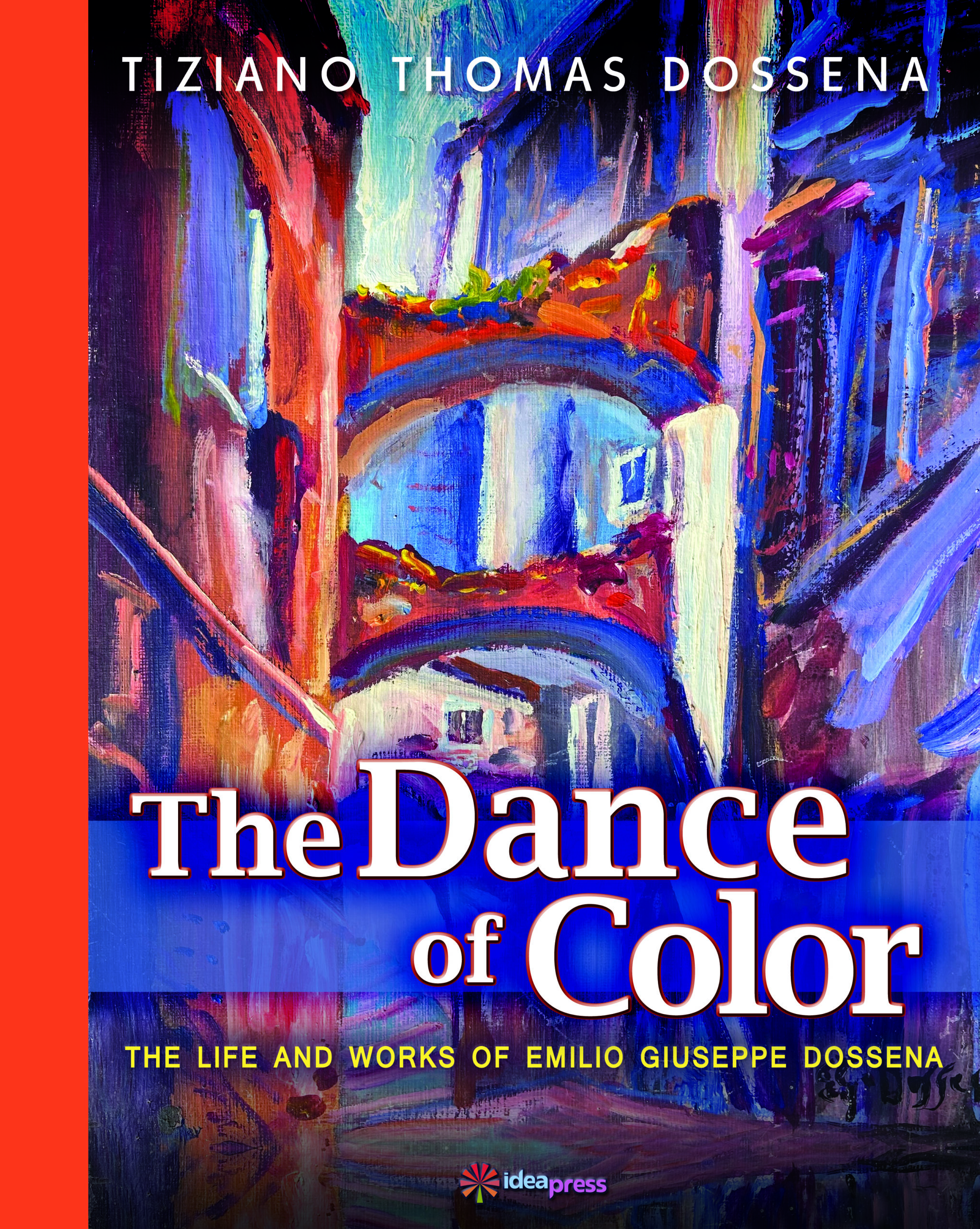Negli ultimi due anni il virus Sars-CoV-2 ha cambiato radicalmente le nostre abitudini: mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione interpersonale vengono usati quotidianamente da milioni di persone. Questi oggetti, fondamentali per la riduzione dei contagi, hanno salvato molte vite ma stanno anche causando numerosi danni ambientali, come evidenzia Matteo Guidotti dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” del Cnr
Quando si parla di impatto del Coronavirus Sars-CoV-2 sulla vita di tutti i giorni tendiamo subito a pensare ai devastanti effetti che la pandemia ha causato sui sistemi sanitari di tutto il mondo, all’impressionante numero di decessi e di persone gravemente malate che porteranno con loro i postumi della malattia per gli anni a venire, al radicale cambio di stile di lavoro e di vita quotidiana e agli ingenti contraccolpi sull’economia globale, in termini di ridotti scambi di persone e di merci. Vi è però un ulteriore importantissimo elemento da tenere in considerazione e che è spesso del tutto trascurato dal punto di vista mediatico: il drammatico impatto che due anni di Covid-19 stanno arrecando all’ecosistema e alla salubrità del nostro ambiente di casa o di lavoro.
L’uso massiccio di dispositivi di protezione individuali e di presidi monouso come mascherine facciali, guanti, visiere e tute protettive, necessari per contenere e prevenire la diffusione dell’agente patogeno da una persona all’altra nei nostri spazi quotidiani, ha portato alla produzione di quantità abnormi di rifiuti non riciclabili e potenzialmente contaminati, con aumenti anche fino al 500% rispetto ai flussi di rifiuti speciali registrati negli anni pre-pandemia. Se la produzione di rifiuti a possibile rischio biologico era, fino a pochi anni fa, una prerogativa di ospedali, cliniche e laboratori medico-sanitari, la diffusione capillare della malattia anche negli ambienti lavorativi e domestici ha fatto sì che questo genere di materiali inquinanti e potenzialmente pericolosi venisse prodotto anche in ambiti non specialistici, andandosi a sommare al normale flusso di rifiuti solidi urbani. In molte città del mondo, infatti, nei periodi più acuti della pandemia, a causa dei numerosi casi di persone positive al virus nelle abitazioni, la raccolta differenziata dei rifiuti è stata sospesa, per indirizzare tutto il flusso di rifiuti verso l’incenerimento o, nei Paesi con le economie più deboli, verso discariche indifferenziate a cielo aperto seguendo il motto “nel dubbio di presenza di materiali infetti, buttare tutto nel sacco nero!”.
Per garantire la sicurezza da contaminazione biologica si è perciò preferito trascurare il modello circolare e sostenibile della gestione dei rifiuti, basata sul trinomio “ridurre, riutilizzare, riciclare”, le cosiddette “3r”, per tornare a un approccio convenzionale di economia lineare della vita di un prodotto: materiale nuovo, singolo impiego, smaltimento come rifiuto. Oltre al possibile rischio infettivo, i dispositivi di protezione impiegati fin dall’insorgere della pandemia sono costituiti da materiali di natura chimica molto disomogenea e, per questo, sono molto difficilmente riciclabili. Ad esempio, le ben note mascherine Ffp2 contengono strati filtranti prodotti con microfibre di polimeri plastici diversi, quali polietilene Pe, polipropilene Pp o polietilentereftalato Pet, accoppiati tra loro. Questa alternanza di materiali diversi garantisce alte prestazioni di filtrazione, ma rende estremamente difficile poter differenziare e riciclare le varie componenti. È stato stimato che siano state prodotte più di 52 miliardi di mascherine nell’anno 2020 e che più di un miliardo e mezzo siano finite negli oceani a causa di uno smaltimento non corretto. Si intuisce quindi quanto grande sia l’impatto ecologico anche solamente dell’uso così esteso di dispositivi facciali. Le stesse mascherine abbandonate nell’ambiente sono inoltre una fonte rilevante di microplastiche nelle acque, dal momento che una singola mascherina chirurgica, per effetto dell’irraggiamento solare e del contatto con l’acqua marina, può rilasciare fino a 173’000 microfibre al giorno.

Anche l’amplissimo uso di igienizzanti e disinfettanti al di fuori degli ambiti sanitari, condotto in modo talvolta sconsiderato e inappropriato – si pensi alle sanificazioni massicce di parchi pubblici, campi sportivi all’aperto e strade nella primavera del 2020 – ha portato a fenomeni di inquinamento dell’aria, del suolo o delle acque, causato da sottoprodotti nocivi generati dall’interazione tra i liquidi biocidi e i composti organici naturalmente presenti in natura. Negli ambienti chiusi domestici e lavorativi si registra ora frequentemente un inquinamento dell’aria superiore alla norma, dato dai composti organici volatili (Cov), che si sprigionano dalle grandi quantità di soluzioni disinfettanti a base alcolica, o di cloro attivo, che vengono disperse sulle superfici o sugli oggetti di uso quotidiano. Analogamente, si sta osservando un’accresciuta resistenza batterica indotta da uso eccessivo nelle case di tensioattivi cationici (soprattutto i prodotti a base di sali di ammonio quaternario, come il cloruro di benzalconio o il cloruro di didecildimetilammonio), i quali, una volta finiti nella rete fognaria, possono generare non pochi problemi ai sistemi di trattamento e depurazione delle acque di scarico urbane.
È chiaro dunque che la grande lotta al Coronavirus con tutti i sistemi di protezione e prevenzione che abbiamo imparato a conoscere in questi due anni non deve cancellare i recenti progressi fatti a favore di una tutela dell’ambiente sempre più attenta e una gestione dei rifiuti sempre più sostenibile. Rispetto al 2020, quando ben poco si sapeva di questo nuovo agente patogeno, è ora possibile impiegare con maggior oculatezza e parsimonia presidi monouso, soluzioni biocide e indumenti protettivi. A tal fine, sempre più ricercatori nel mondo, e anche nel Cnr, stanno lavorando per sviluppare dispositivi di protezione riutilizzabili e riciclabili, principi attivi disinfettanti ecocompatibili e linee di condotta operative più sostenibili che possano coniugare sicurezza per la salute umana e salvaguardia dell’ambiente, cosicché l’uscita dalla fase emergenziale della pandemia vada di pari passo con una netta riduzione dell’impatto ecologico delle contromisure messe in atto per contrastarla. [Almanacco della Scienza N.10, 2022]