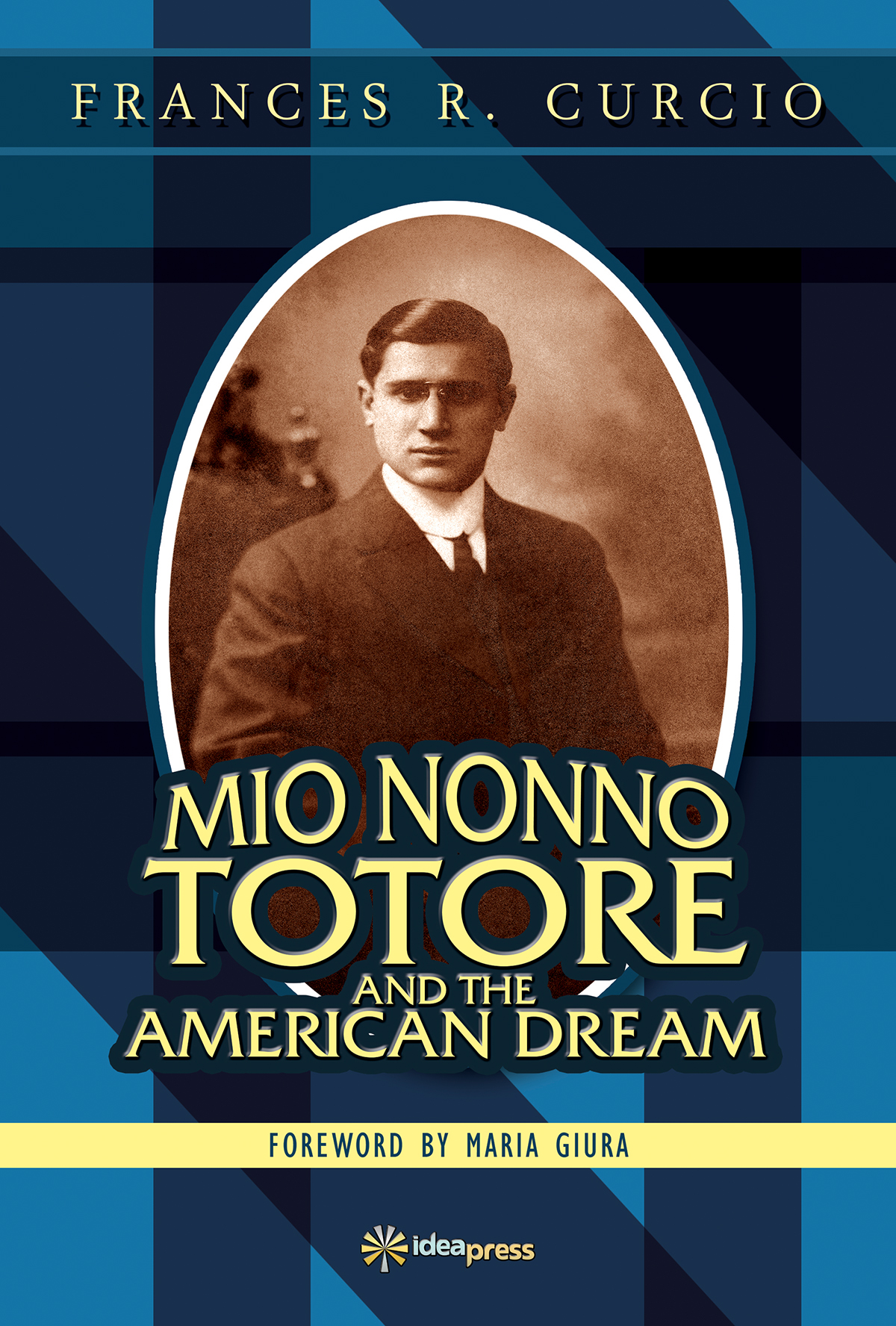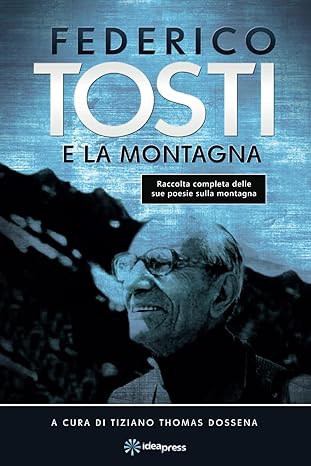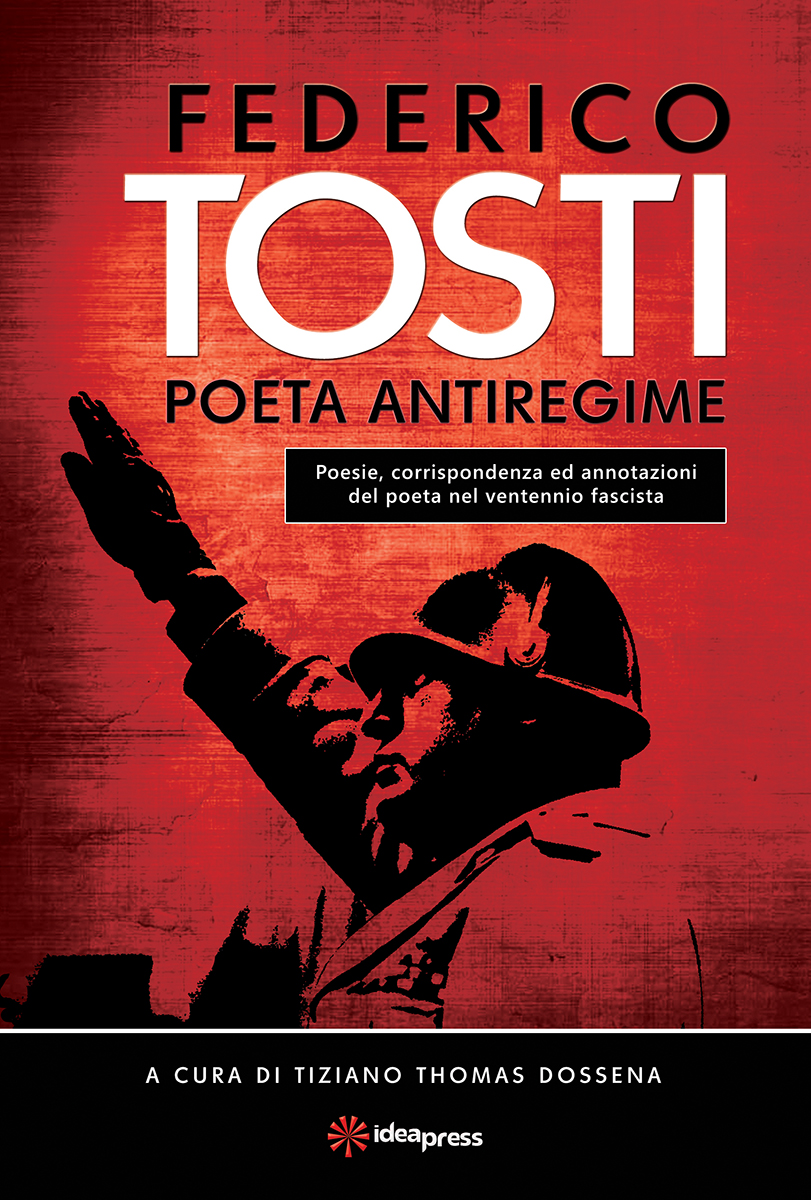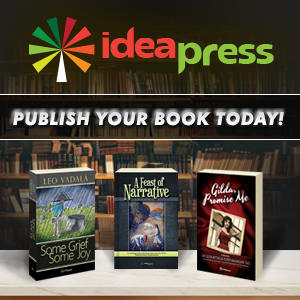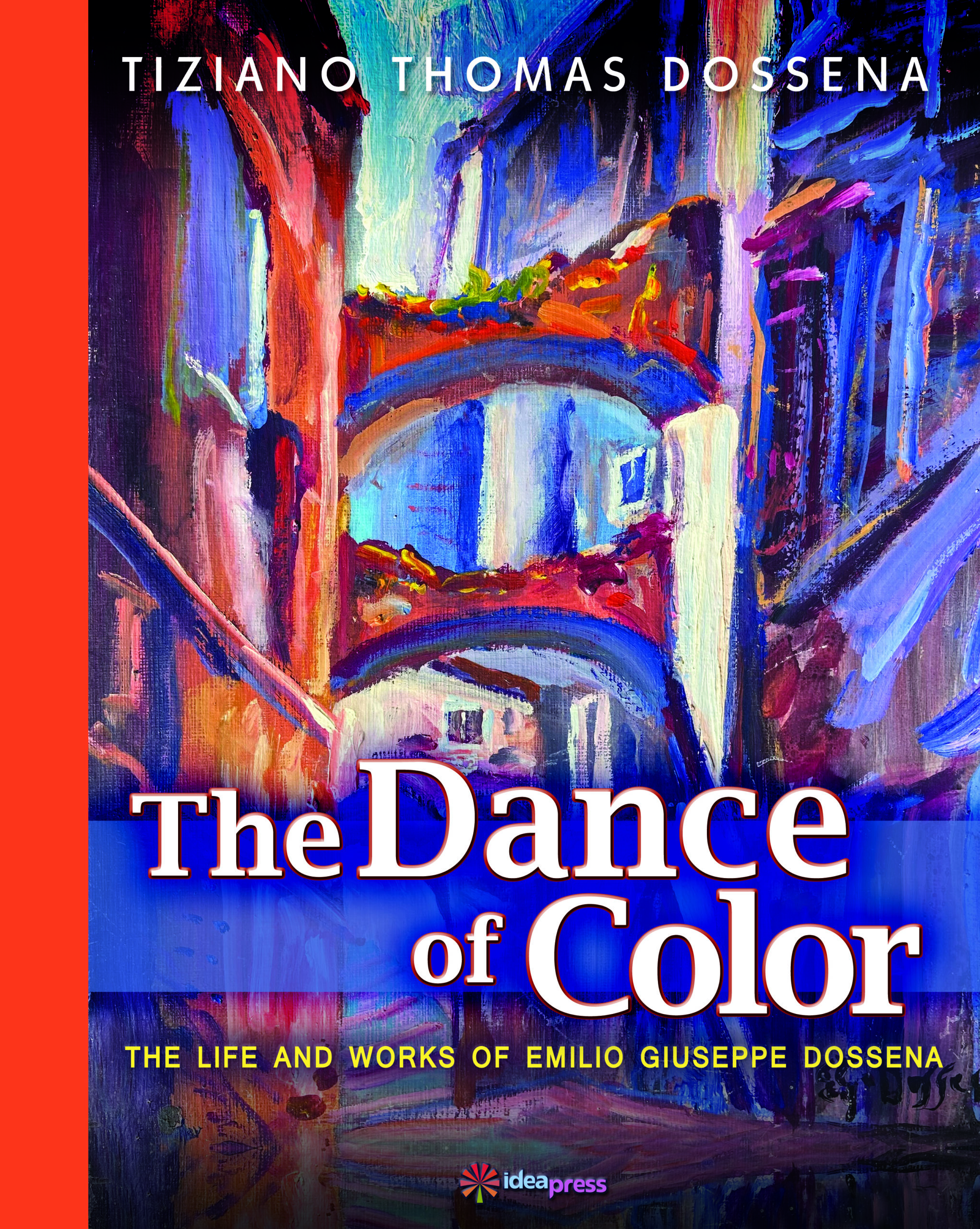Il cervello umano formula pensieri a soli 10 bit al secondo, mentre i sensi elaborano informazioni velocissime a miliardi di bit. Dietro questa lentezza si nasconde il segreto del pensiero profondo. Ne abbiamo parlato con Maria Luisa Malosio, ricercatrice dell’Istituto di neuroscienze del Cnr
Perché formuliamo un solo pensiero alla volta, nonostante l’enorme mole di informazioni sensoriali che riceviamo? Un recente studio del California Institute of Technology di Zheng e Meister, pubblicato su “Neuron” ha esplorato il funzionamento del cervello umano, che sembra andare a due velocità, come chiarisce Maria Luisa Malosio dell’Istituto di neuroscienze (In) del Cnr: “Da una parte abbiamo un cervello esterno, che processa contemporaneamente segnali sensoriali e motori alla velocità di un miliardo di bit al secondo dall’altra abbiamo un cervello interno, che ha una velocità di processamento di 10 bit al secondo – 100 milioni di volte in meno – per elaborare i pensieri e prendere decisioni. Ed è proprio al cervello interno che spetta il compito di associare e integrare diversi tipi di informazioni, anche quelle già memorizzate, controllando il comportamento umano in modo altamente selettivo e seriale”.
Riconoscere un volto, afferrare un oggetto, scavalcare un ostacolo sono processi automatici guidati dai nostri sistemi sensoriali che funzionano in modo parallelo ad alta velocità, mentre compiti come scrivere, parlare e giocare ai videogiochi avvengono a una velocità di informazione vicina ai 10 bit al secondo. “L’elaborazione delle informazioni è specifica del comportamento umano e include l’integrazione tra cognizione, funzione motoria e percezione; sembra funzionare in modo seriale, a collo di bottiglia, e in modo sorprendentemente lento, nonostante l’enorme numero di neuroni presenti nel cervello. Ciò suggerisce un compromesso evolutivo: l’integrazione delle informazioni propria della cognizione è limitata da strutture neurali che si sono evolute per risolvere problemi ‘singoli’ piuttosto che per il multitasking parallelo, tipico degli automatismi comportamentali”, spiega la ricercatrice.
Ma 10 bit al secondo è tanto o poco? Zheng e Meister, nel loro lavoro, cercano di darci l’idea di questa dimensione con alcuni esempi: la soluzione del cubo di Rubik avverrebbe da parte di persone allenate con una velocità di percezione di 11.8 bit al secondo. “Dopo un viaggio in elicottero di 45 minuti, un artista in grado di disegnare su una griglia 1.000 edifici, identificabili ciascuno con uno dei 1.000 stili possibili, tutti disegnati correttamente, avrebbe acquisito le informazioni per il dipinto a una velocità di 4bit al secondo”, aggiunge Malosio.
Ma come scegliamo quei 10 bit così cruciali per le nostre decisioni? “Il cervello è diviso in due emisferi – il destro e il sinistro – e ognuno è responsabile di determinate funzioni. Il sinistro è responsabile del linguaggio e del pensiero logico, mentre il destro è responsabile del pensiero creativo e delle emozioni. Alcuni studi hanno dimostrato che l’emisfero destro del cervello influenza pesantemente l’attenzione selettiva. Anche una regione del cervello, chiamata corteccia prefrontale è importante per l’attenzione selettiva, è responsabile del processo decisionale e si occupa di filtrare le informazioni irrilevanti. La comunicazione tra i neuroni all’interno del cervello avviene tramite neurotrasmettitori, come la dopamina e ormoni come l’adrenalina, che ci aiutano a rimanere concentrati”, afferma Malosio. “A influire sull’attenzione selettiva è la dopamina che viene rilasciata quando proviamo piacere o soddisfazione. Ci aiuta a rimanere concentrati su determinati compiti o stimoli, bloccando allo stesso tempo gli stimoli di distrazione”.

L’attenzione selettiva svolge quindi un ruolo importante nel processo decisionale, anzi è fondamentale per prendere le decisioni migliori. Aiuta a concentrarsi su ciò che è rilevante e a dare priorità ai compiti da svolgere. Aiuta anche a ignorare le informazioni irrilevanti e le distrazioni. “Per esempio, un chirurgo può filtrare il rumore irrilevante in una sala operatoria per concentrarsi sul compito da svolgere in modo più accurato. E questo è proprio il modo di funzionare del cervello interno”, aggiunge l’esperta.
Il cervello rappresenta il 2 % della massa corporea, ma consuma il 20 % dell’energia che ci serve per vivere. Nel suo insieme, l’attività cerebrale nell’uomo consuma quindi la maggior parte dell’energia. “Gli studi di Maurizio Corbetta, professore dell’Università di Padova, mediante l’imaging funzionale sul cervello umano hanno messo in evidenza che il cervello consuma energia per mantenere e perfezionare le proprie funzioni di base anche in assenza di stimoli esterni e si stima che questo rappresenti il 90% del consumo energetico del cervello” racconta Malosio.
Questo fenomeno potrebbe essere il risultato di un adattamento evolutivo. I nostri antenati, infatti, dovevano prendere decisioni rapide e immediate per la sopravvivenza: dove andare, come orientarsi, come evitare il pericolo e assicurarsi il cibo. “Secondo la teoria di Zheng e Meister, tali decisioni probabilmente rientrano nell’ambito del ‘cervello esterno’, mentre l’evoluzione della cultura caratteristica dell’uomo sapiens rientra nell’ambito del ‘cervello interno’ e ha contribuito al successo evolutivo e alla nascita dei tanti ambiti disciplinari che spaziano dalle scienze umane e cognitive alla scienza e tecnica, dalla ricerca scientifica alla medicina; la base cognitiva per inventare soluzioni tecnico-scientifiche, sociologiche, economiche e mediche che rispondono alle tante sfide umane”, continua la studiosa del Cnr-In.
La lentezza del pensiero razionale sembra oggi in contrasto con un mondo che corre, che premia l’immediatezza e fa della velocità il motore della vita. Siamo tutti affascinati, ma anche stressati dalla velocità, costretti ad aggiornamenti continui e a far fronte a tecnologie che si rinnovano e diventano presto obsolescenti. “In questo mondo veloce abbiamo però un alleato: le reazioni automatiche del nostro sistema sensoriale, che ci permettono di rispondere in fretta agli stimoli ambientali, ma per formulare riflessioni profonde e durature serve tempo e non dobbiamo avere paura di stare al passo delle nostre capacità cognitive”, commenta Malosio.
È dunque bene aver cura del nostro cervello lento, perché come ricordava il neuroscienziato Lamberto Maffei, già presidente dell’Accademia dei Lincei e direttore del Cnr-In dal 1980 al 2008, nel suo “Elogio alla lentezza”: “il cervello è un organo che ha bisogno di lentezza”. Difendere e coltivare il pensiero lento significa preservare ciò che rende unico il nostro modo di pensare e imparare.
“Il cervello è ottimizzato per la sopravvivenza, non per una cognizione illimitata. Opera sotto stretti vincoli energetici, il che significa che dà priorità all’elaborazione automatica e a basso sforzo con il cervello esterno, mantenendo come ultima risorsa il ragionamento cosciente e deliberato con il cervello interno. Questo compromesso tra pensiero veloce e lento è profondamente radicato nelle nostre reti neurali, nell’attività cerebrale spontanea e nei limiti metabolici”, conclude Malosio.
Comprendere questo aspetto può aiutare a spiegare perché la cognizione umana ha dei limiti, perché sperimentiamo la stanchezza mentale e perché il multitasking è difficile. Dobbiamo però resistere alla tentazione di abbandonare il pensiero lento a favore della facilità decisionale offerta dall’esposizione a tanti mezzi che ci propinano soluzioni ad alta velocità, perché alla lunga ci renderebbe meno umani.
[L’alamacco della Scienza N.2 febbraio 2025]