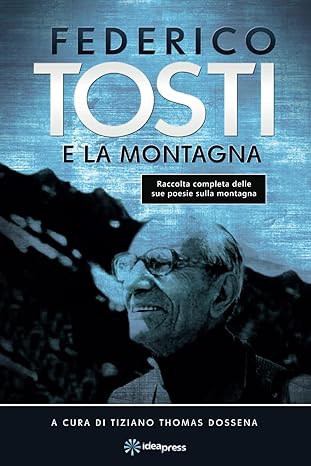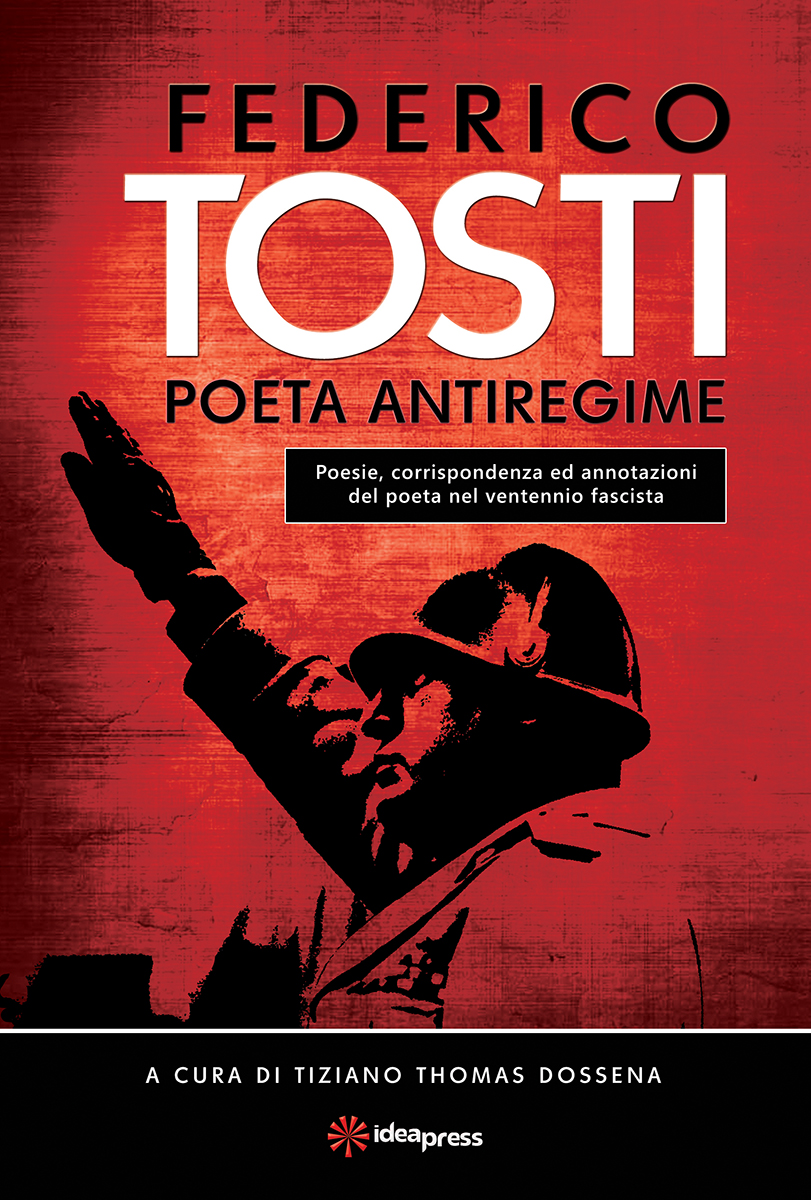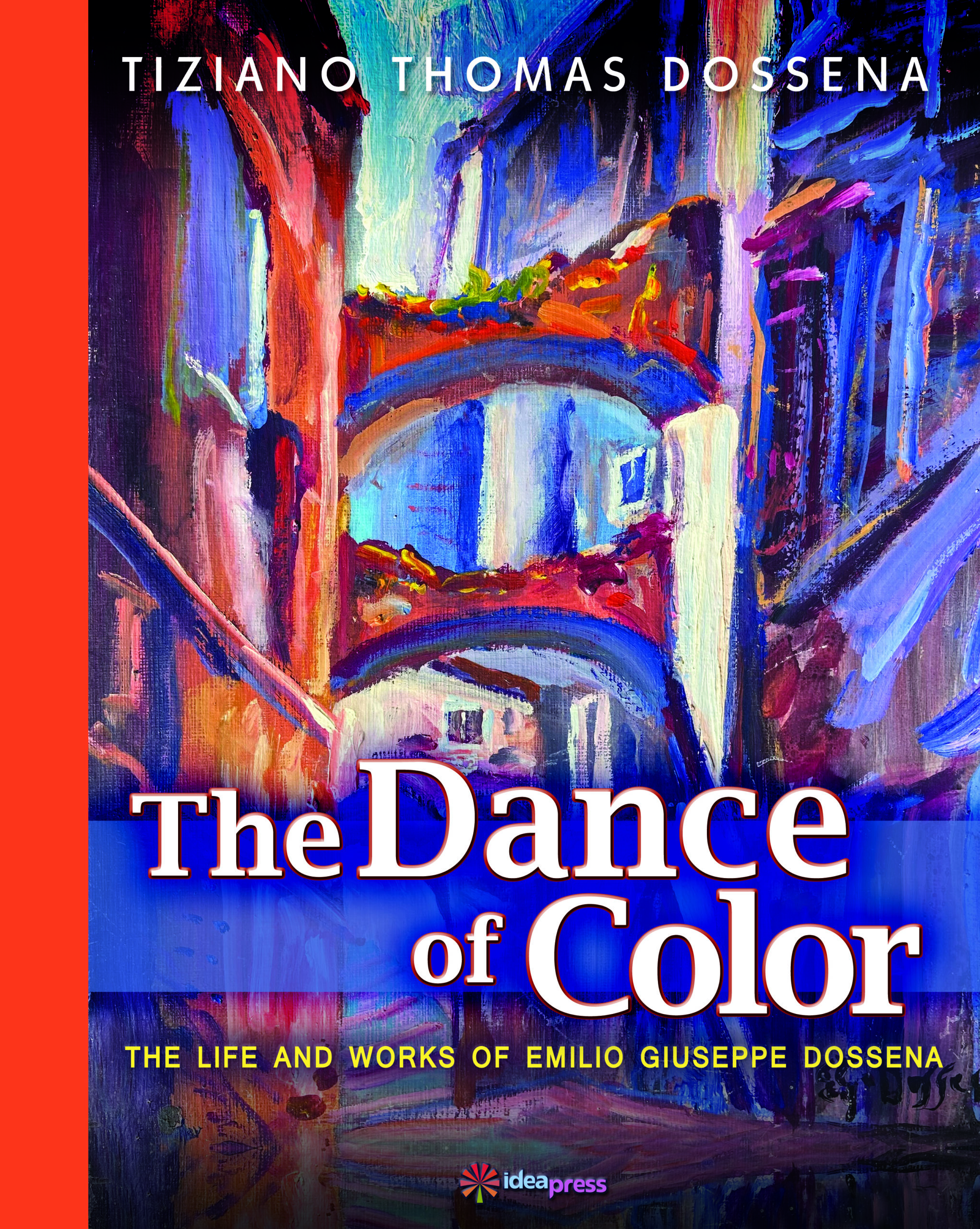di Laura Klinkon
‘Megghiu lu tintu di bona razza, ca lu megghiu di mala razza…’
In vista delle vicende recentamente accadute nella famiglia reale brittanica, non dovrebbe sorprendere se rivisitiamo il romanzo La Zia Marchesa di Simonetta Agnello Hornby, che descrive le relazioni difficili che possono sorgere nell’ambito di una famiglia nobile. Oggi si è paragonata la monarchia brittanica a una grande impresa con circa quattro mila impiegati. Certo che il numero di “impiegati” è molto più basso nei palazzi dei Safamita, la famiglia protagonista del romanzo di Agnello Hornby. Ma il problema che circonda Harry e Meghan ha base nel bi-razzialismo di Meghan, in cui lei viene considerata proveniente da un ceto basso. In mezzo a tanti impiegati con vari giudizi e pregiudizi, è molto possibile che alcuni la guardino con poco rispetto. L’Agnello Hornby, vivendo da anni in Inghilterra, si sarà forse accorta di simili problemi nella società brittanica.
Uno dei suoi personnaggi, Stefano Safamita, figlio del barone Domenico, viene ripudiato dal padre perché ha sposato una figlia di un ferraio e quindi, non nobile—per di più, il ferraio sembra intralciare politicamente la gestione della loro proprietà terriera. Le consequenze per Stefano e la sua giovane famiglia sono dure. Anche se non si tratta di razza nel senso moderno, un proverbio siciliano segnala che è “Meglio il cattivo di buona razza, che il migliore di mala razza,” in cui “razza” è sinonimo ironico di ‘ceto sociale.’
In La Zia Marchesa, avvengono tante discordie, fra cui le più stravolgenti nella famiglia dei nobili. Le vicende del romanzo attirano il lettore per l’acuta ironia e il lento passo delle rivelazioni. Sperando che il caso di Harry e Meghan non finisca come alcuni di questo romanzo, vi aggiungo una recensione mia scritta prima dell’affare brittanico reale, che spero potrà divertire, se non accennare al tipo di discordie che possono accadere nelle famiglie nobili.
Nel romanzo di Simonetta Agnello Hornby, ambientato vicino a Palermo nella seconda metà dell’ottocento, incontriamo tanti personaggi, quasi tutti parenti o anziani servitori dei Safamita, con cognomi che sembrano tratti da programmi di cabaret! Non sono subito percepiti come tali, sia per le tante espressioni siciliane che fanno parte del colore locale, sia per il coinvolgente svolgimento del romanzo.
Quanto al motivo di questi nomi sbalordenti mi sono incuriosita parecchio. I cognomi italiani come quelli di altre etnie sono spesso basati sul nome di un luogo di residenza, sul nome di un nonno, di un mestiere praticato, di una carica ufficiale di qualche antenato, oppure su un soprannome risalente a qualche avo. La zia marchesa, sfrutta un po’ tutte queste derivazioni, ma la maggior parte dei cognomi rassomigliano a soprannomi, e in molti si manifesta una trasparente ironia.
Il primo cognome che mi ha lasciata attonita appartiene a un personaggio secondario, una serva che lavora come aiuto cuoca a Palazzo Safamita, di cognome Munnizza. Da siciliana d’origine, ho capito subito che Munnizza vuol dire immondizia, un servizio di cui questa serva potrebbe bene occuparsi. Ma la scelta dell’autrice l’ho capita meglio solo rileggendo le vicende di Lina Munnizza, da anni amante di un impiegato del castello che viene poi trasferito in un altro palazzo. Presa d’invidia verso una balia che ha un ruolo molto importante nel romanzo e che continua a godere di una relazione amorosa in situ, Lina decide di denunciarla. Con questo nome, l’autrice sembra disprezzare la bassezza di questa serva ma è anche interessante che la denunziata, perché molto apprezzata in famiglia, non viene nemmeno rimproverata.
Il secondo cognome che mi ha colpito non è di un servo, bensì del Cavaliere Calliasalata e sua moglie Alfonsina. In questo caso, mi sembra che l’autrice, con un piccolo trucco, abbia camuffato il significato del nome, altrimenti facilmente decifrabile, raddoppiando la “elle” della parola “calia” che indica anche in italiano ceci abbrustoliti, qui conditi di sale. Durante un viaggio in treno, Alfonsina incinta, dorme accanto alla sua cugina infeconda, ispirandole gelosia con il suo ventre molto evidente. Più tardi a passeggio con la stessa cugina, Alfonsina, intenditrice di bellezza maschile, le segnala alcuni robusti giovinotti. Mi rendo conto che come nell’espressione inglese, che vuol dire “piena di fagioli,” Alfonsina Calliasalata potrebbe essere “piena di energia” oppure (secondo la versione americana) “piena di stoltezza.” L’aggettivo “salata” aggiunge un elemento birichino.
È anche vero che i soprannomi utilizzati da Agnello Hornby, non solo si riferiscono al comportamento del personaggio, ma spesso ai loro rapporti con gli altri. Ad esempio, i cognomi di alcune serve dei Safamita—Aiutamicristo, Nascimbene, e Vinciguerra—cameriere personali, sembrano più adatti ai loro padroni: Caterina Safamita, chiusa e malandata oltre ogni possibile aiuto, Costanza che ebbe una nascita affatto benvenuta, e Stefano, che come figlio repudiato, perde pateticamente la sua battaglia.
Il significato nascosto di altri cognomi non s’indovina tanto facilmente, forse perché collegati a espressioni gergali. C’è, a tal proposito, un personaggio molto importante che controlla tutte le terre dei Safamita e si chiama Peppi Tignuso (tignuso in siciliano sta per calvo). E c’è, infatti, l’espressione, “Lavare la testa al tignuso,” che vuol dire beneficare chi non ne è grato. L’autrice così ammicca al “rispetto” per i padroni ripetutamente dichiarato da Tignuso, che in fondo gli manca. Quanto al notaio Tuttolomondo, si capisce che il suo cognome è legato al fatto che spetta a lui certificare le faccende di tutti—anche quelle poco oneste.
La scoperta forse più intrigante è quella del significato del cognome “Patella di Sabbiamena” del marito della protagonista principale, Costanza Safamita. Si sa comunemente che la patella fa parte del ginocchio e ne protegge l’articolazione; l’ironia del cognome sta nel fatto che questo marito ha dovuto inginocchiarsi parecchie volte davanti a Costanza per le sue mancanze nel dovere matrimoniale. La “patella” poi, è anche il nome di una lumaca marina, e da questo percepiamo un’ironia anche più pungente: Costanza da piccola, impressionata da una favola raccontata dalla sarta di palazzo, si è identificata con una “Principessa Babbaluce” (babbaluce in siciliano sta per lumaca). Così, Costanza sembra essersi sposata con un suo simile, anche se il matrimonio si è alcune volte macchiato di infedelità, congiunto alla mancanza d’affetto.
La nomenclatura dei personaggi in La zia marchesa di Simonetta Agnello Hornby ha una funzione molto rilevante seppur velata da maschere ironiche. Porgo ai lettori alcuni altri cognomi dei personaggi che si capiscono subito lessicalmente, Puma, Sedita, Leccasarde, Lattuca, Pelonero, Mercurio, Piscitelli, Quagliata, La Cirara. di cui, si potrebbe benissimo trovare il sottinteso.
L’ultimo di questi cognomi, cioè della sarta cantastorie, spicca fra tutti gli altri, perché l’autrice insolitamente sembra di rivelarne il significato, spiegando che La Cirara (parola siciliana che indica una “lavoratrice della cera”), da sarta, non ha mai lavorato la cera, però, suo marito, morto dopo pochi anni di matrimonio, aveva fatto il candelaio—una spiegazione doppiamente ironica, visti i tanti altri significati lasciati in ombra.
Il mistero del motivo per questi soprannomi rivelatori si presenta. Per la maggior parte, a portarli sono i personaggi secondari o di terzo grado, al contrario dei nomi degli aristocratici che sono quasi sempre indicati col solo nome di battesimo. Giacché sono piuttosto umoristici, siamo portati a pensare che intendono schernire chi li porta. Ma, come abbiamo visto, anche i cognomi degli aristocratici sono ironici. Il nome Safamita, se aggiustiamo bene la lente, si riferisce ad una fama protetta da forte riserbo, o danneggiata per ostinato orgoglio, o mantenuta da una via crucis di sottomissione. Anche in alcuni loro prenomi si percepiscono connotazioni: Assunta Safamita è monaca di casa, spesso beneficando monasteri e conventi, tutto con lo scopo di essere eventualmente santificata; Costanza, anche in disaccordo con la famiglia per il ripudio del fratello maggiore, accetta di vederlo in segreto, ma lo esclude dalle riunioni con altri nobili; Domenico, perlopiù pacifico, è propenso ad accessi passionali saltuari.
Invece, i personaggi del ceto dei servi, anche se ce ne sono di spregevoli fra di loro, sembra accettare la propria sorte, resistere con forza, astuzia, o magari benevolenza alle privazioni e sofferenze, adempiendo ai propri doveri con dedizione. Eppure, l’autrice persiste a dare loro dell’umoristico— ad esempio, Gaspare Quagliata cameriere personale di Domenico, che, in alcune vicende, con un metaforico spruzzo di aceto, riesce a risolvere portandole a galla, alcune faccende del palazzo. Oppure la balia Amalia Belice Cuffaro, nel cui nome si sentono le parole ammaliare, abbellisce, e coiffeur, passa ore ad acconciare i capelli rossi della sua affidata, e più tardi, a pettinare le trecce di sua nipote inferma.
Quindi, cosa intende l’Agnello Hornby con tutti questi soprannomi? Essi esprimano un certo disprezzo, ma il genio con cui sono inventati suggerisce anche affetto, ma soprattutto l’intenzione di far notare il carattere del personaggio. Entra anche in gioco come sono distribuiti: coi servitori e i nobili di secondo grado quasi sempre usa nome e cognome, suggerendo rispetto; mentre nobili di primo grado (che si crede lo meritassero di più), di solito vengono chiamati col solo prenome. Che l’autrice voglia ricordarci ironicamente di un’epoca in cui i poveri senza nome venivano trattati come tali? Così, intanto, fa considerare al lettore, se questi personaggi sono “nobili” o no, “rispettabili” o no, amabili o no—insomma, se sono di buona o cattiva “razza.”