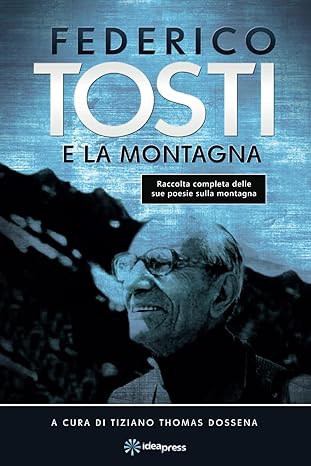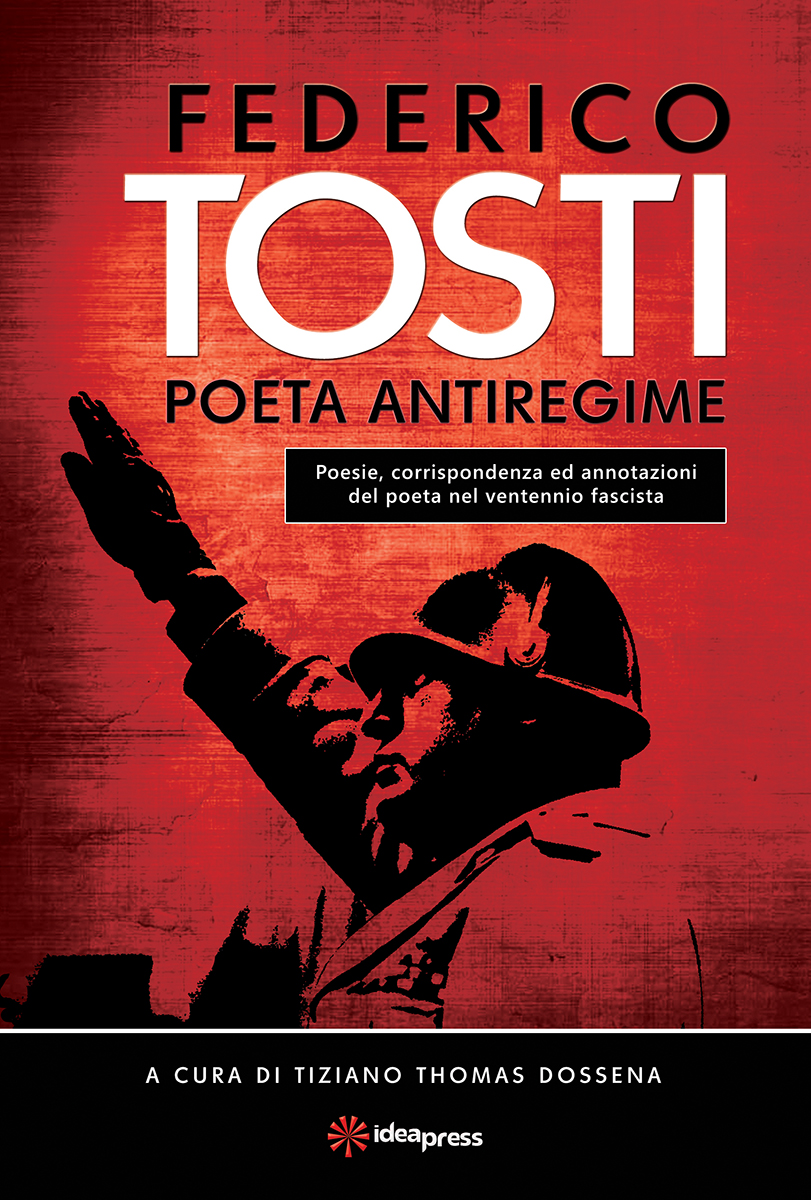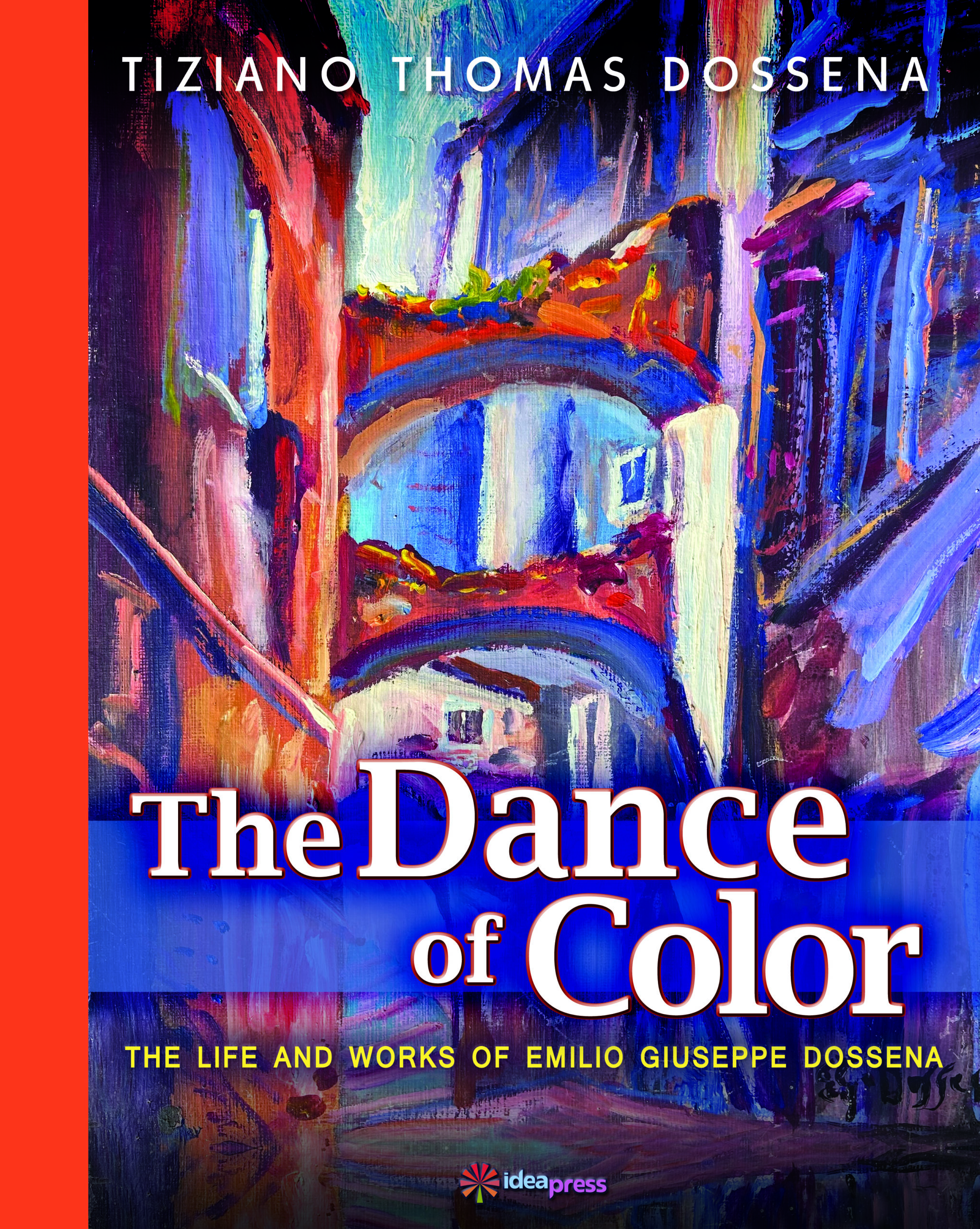Termini tipici dei social media, come “hashtag”, “like” o “meme” sono sempre più diventati parte del lessico quotidiano, semplificando e rendendo più immediata la comunicazione anche grazie alle emoji. Purtroppo, però, questa semplificazione ha favorito anche fenomeni negativi come l’hate speech o il cyberbullismo. Di fronte a questo scenario, i giuristi hanno cominciato a interrogarsi sulla responsabilità delle piattaforme e su nuove tutele contro odio e discriminazione. Ne parliamo con Francesco Romano dell’Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari del Cnr
Il linguaggio dei social media, con termini come “hashtag”, “like” e “follow”, è diventato ormai parte del lessico quotidiano. Altre espressioni come “meme” e “cringe” sono ora comprensibili da molti. Anche le emoji hanno introdotto un nuovo modo visivo di esprimere emozioni e concetti, rendendo la comunicazione più immediata e sintetica. Tuttavia, questa evoluzione ha anche un lato oscuro: la semplificazione del linguaggio ha contribuito a diffondere fenomeni negativi come l’hate speech (linguaggio d’odio) e il cyberbullismo, amplificando l’aggressività e la polarizzazione, contribuendo a rafforzare le divisioni tra gruppi di persone con opinioni opposte. Sui social media, le discussioni tendono a estremizzarsi, perché la piattaforma stessa, attraverso algoritmi che favoriscono l’engagement, promuove contenuti che suscitano forti reazioni emotive, come rabbia o indignazione. Questo meccanismo finisce per creare “bolle” di persone con idee simili che si rafforzano a vicenda, rendendo più difficile il dialogo con chi ha opinioni diverse e aumentando la distanza tra gruppi con visioni contrastanti.
Questo nuovo scenario ha portato anche i giuristi a interrogarsi su argomenti quali la responsabilità del social media provider per i contenuti diffusi in Rete o la necessità di nuove e più efficaci tutele per contrastare i sempre più diffusi fenomeni di odio e discriminazione, soprattutto, nei confronti dei più giovani. In questo contesto, l’Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari (Igsg) del Cnr, che da sempre si occupa di linguaggio e, in modo particolare, di linguaggio giuridico, ha ampliato il proprio ambito di ricerca in un’ottica interdisciplinare, per sviluppare attività sui linguaggi dei media tradizionali e dei nuovi media, come i social appunto, anche al fine di verificarne l’impatto sulle democrazie.

Nel volume ‘Social media e diritti. Diritto e social media’, curato da Gian Luca Conti, Marina Pietrangelo e Francesco Romano, autorevoli esperti della materia hanno verificato i profili di responsabilità connessi all’uso di questi media, le possibili alterazioni del processo democratico, ma anche le prospettive che si aprono per la pubblica amministrazione con l’utilizzo di questi strumenti. “Anche il legislatore, in modo particolare quello europeo, si è mosso per regolare questo settore. Basti pensare alle norme del DSA (Digital Services Act) che, oltre a voler proteggere i consumatori e i loro diritti fondamentali, vuole definire responsabilità chiare per le piattaforme online e i social media, ponendosi anche come obiettivo quello di gestire i contenuti e i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione”, afferma Francesco Romano del Cnr-Igsg, “La riflessione su questi argomenti è proseguita nell’ambito di un ciclo di seminari che abbiamo organizzato, con la collega Marina Pietrangelo, nel corso delle attività legate al centenario del nostro Ente. Abbiamo così parlato del linguaggio d’odio con alcuni tra i massimi esperti della materia e, attraverso le pagine del libro di Claudia Bianchi “Hate Speech. Il lato oscuro del linguaggio” (Laterza), abbiamo imparato cosa sia ‘l’ingiustizia discorsiva’ e cioè quel fenomeno che vede le parole degli appartenenti a un gruppo sociale discriminato avere meno potere nei confronti degli interlocutori. Così come, dialogando con Federico Faloppa, autore del volume ‘La farmacia del linguaggio’ (Alpha & Beta), abbiamo potuto verificare come le insidie del linguaggio d’odio si possano talora celare tra le pieghe di parole che paiono innocue, ma che invece sono fatte per ferire, quando, ad esempio, non si usano i giusti titoli per riferirsi a determinati interlocutori, come quando rivolgendosi a una professionista non si usa il titolo che le andrebbe riservato e cioè dottoressa o professoressa, ma la si appella chiamandola signora”.