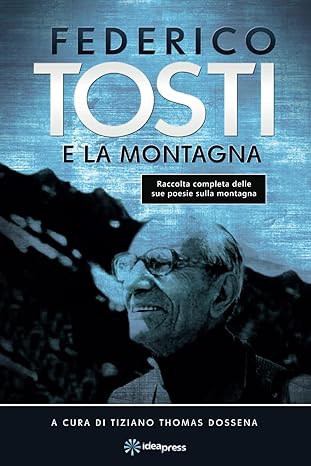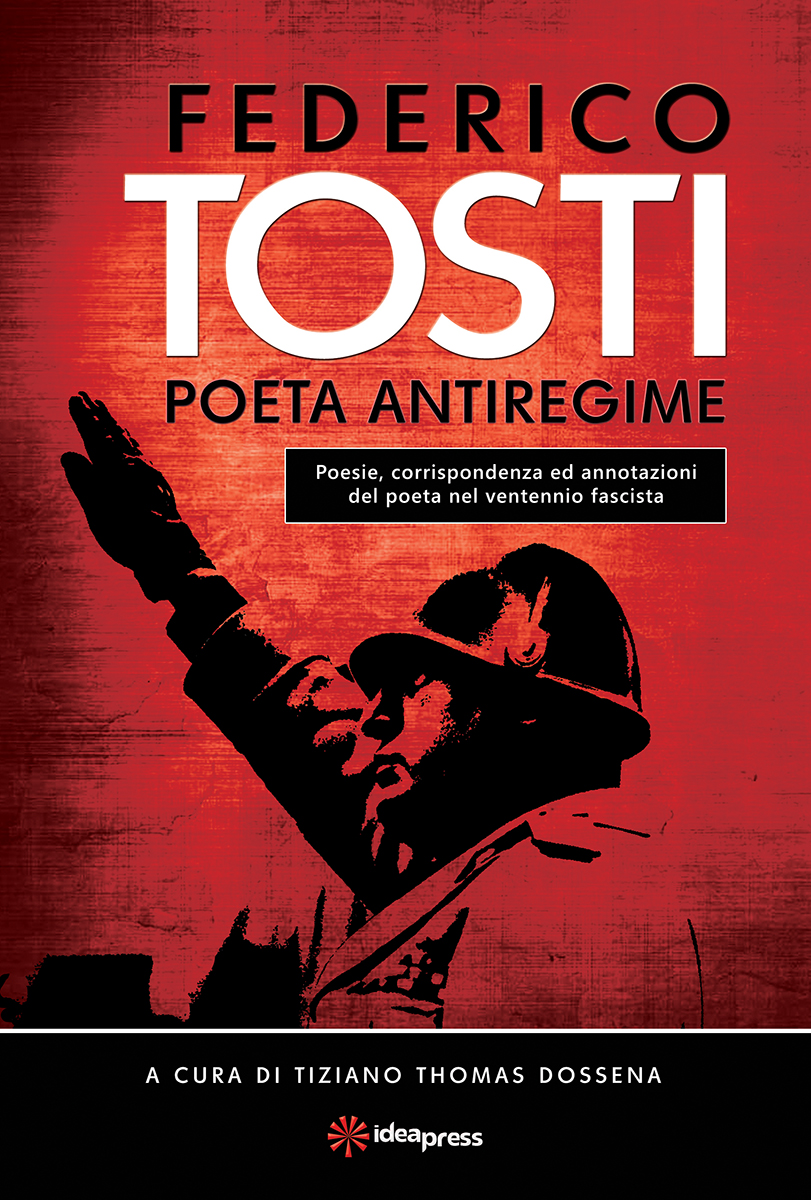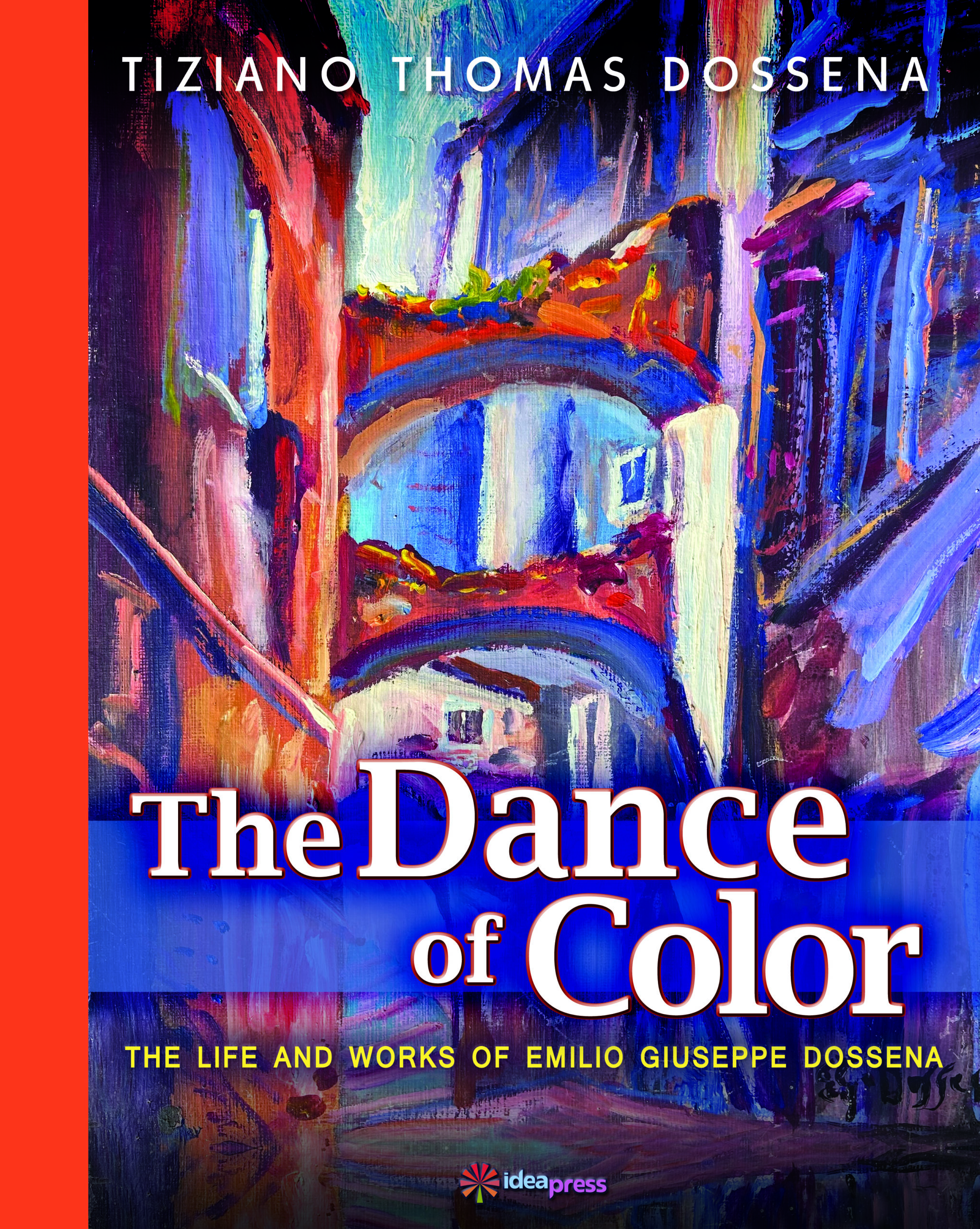Racconto ed illustrazione di Bruno Pegoretti
A Nasturzio Tremolucci piaceva un sacco la pizza, tuttavia se la gustava raramente.
I capelli neri stavano ingrigendosi sulle tempie.
D’aspetto piacevole, aveva denti allineati e bianchi. Sorrideva raramente.
Era più alto della media.
Leggeva e fantasticava.
Guardava troppo la tivù.
Aveva appena compiuto quarantatré anni.
Nasturzio Tremolucci era vergine.
Poco dopo l’adolescenza, verso i diciotto o i diciannove anni, affiorarono i primi sintomi, presagio della sua disgrazia. Tutto cominciò quando, trovandosi a chiacchierare con una ragazza, le sillabe presero inspiegabilmente a incepparsi l’una contro l’altra, così che esse, nel tentativo di formulare parole compiute, s’ingorgavano smozzicate, a casaccio, raggrumandosi in un ammasso contorto sulla punta della lingua, per impastoiarsi infine in un appallottolato oscuro di dittonghi che s’intralciavano gli uni contro gli altri, nello sforzo affannoso ed inutile d’uscire.
Per quanta caparbietà Nasturzio Tremolucci ci mettesse, quelle ingrate lallazioni male masticate se ne stavano impantanate nella saliva, e lì vi annegavano.
“Carino, quello”, diceva una ragazza nel vederlo passeggiare per il Corso.
“Carino e scemo: non sa neppure spiccicare una parola”, si sentiva rispondere dall’amica.
Nasturzio s’illuse che fosse un blocco temporaneo. “Passerà”, si diceva.
La fantasia sperata non solo non si avverò, ma le cose andarono via via peggiorando. Finì, col trovarsi nell’interagire con una donna, a sproloquiare vaghi monosillabi tartagliati, riducendosi in ultimo a sputacchiare miserandi fonemi intervallati da monchi suoni gutturali, intellegibili anche a se stesso. Poi, null’altro.
Aveva vent’anni, l’eternità davanti e la consapevole condanna, senza redenzione, d’una solitudine sterile. Innamorarsi, fare dei figli, crescere una famiglia felice: ciò che più desiderava gli era negato da una sorte ineluttabile.
Si chiuse in casa e infradiciò di lacrime disperate la spalla reumatica di mamma Mimosa, l’unica donna con cui era in grado di condividere la sua iattura.
Addolorata, la santa donna lo accompagnò da vari specialisti: psicologi, logopedisti, otorinolaringoiatri… Interpellati, i luminari sentenziavano genericamente: “Mai visto un caso simile…”, scrollavano le spalle e indirizzavano mamma Mimosa dalla segretaria per saldare il consistente onorario.
Nella costretta segregazione, Nasturzio riempiva quadernoni di parole, pensieri e racconti che mai avrebbe potuto condividere con una donna. Scriveva, e fantasticava spesso di quando, poco più che bambino, nel mare dell’immaginazione, ci nuotava da campione. A volte un’onda improvvisa lo cacciava sotto. Lui emergeva, sputava salato e riprendeva con bracciate temerarie. Raggiungeva le boe, ultimo baluardo anche per i più esperti, e le superava: non di molto, ma le superava. Virava oltre le Colonne d’Ercole, dove sostava a riprender fiato, e là s’intratteneva con donne d’incanto, metà femmine e metà pesce, avide di sesso, e s’imbatteva sovente con giganti dai bicipiti ipertrofici, che stendeva con la forza delle sole mani nude.
Salutava, ricambiato, serpenti marini lunghi un chilometro. Ritornava a riva stremato, trattenendo negli occhi il turgore dei seni ingordi delle sirene. Fantasticava. Fantasie antiche.
Si riduceva a guardare, non guardando, insulsi programmi alla tivù. Verso le dieci di sera dava il bacio della buonanotte a mamma Mimosa e andava a dormire.
Nasturzio Tremolucci non usciva quasi mai: il terrore d’incontrare una donna e, peggio, di dover parlare con lei, lo paralizzava. Solo raramente si trovava con i tre amici più cari, unici custodi del suo segreto. Assieme si vedevano per una pizza. Si sedevano e quando la cameriera si rivolgeva a lui con un gentile: “Che cosa le porto?”, rispondevano all’unisono gli amici, esperti dei suoi gusti: “Una quattro stagioni e una birra media.”
Quando non ne poteva più d’essere recluso in casa, sgattaiolava guardingo in vicoli solitari, nell’ora in cui la gente è solita desinare, protetta dalla discrezione delle mura domestiche. Una volta capitò che, durante una passeggiata serale, gli si avvicinò una donna. Nasturzio, col cuore a mille, volse lo sguardo altrove. La donna lo chiamò:
“Scusi!… Scusi!… Sa che ore sono?”
Nasturzio tese il braccio con l’orologio verso di lei, ficcandoglielo quasi sotto il naso.
“Grazie”.
Lui sorrise e alluse a un inchino.
Aveva compiuto i ventitré anni, pencolava per la casa come un malinconico animale preso in prestito, aiutava mamma Mimosa nelle faccende d’ogni dì e spesso preparava pranzo e cena per entrambi. I soldi languivano e le uniche braccia forti erano quelle di Nasturzio. Che fare? Come mandare avanti la baracca senza scontrarsi con l’universo femminile, pronto ad aggredirlo appena schiusa la porta?
Va detto che Nasturzio Tremolucci abitava in un meraviglioso borgo affacciato sul mare, le cui case seguivano la curva dolce della baia raccolta. Dietro, le colline terrazzate trionfavano di viti, alberi da frutto e spezie, il cui aroma, profuso nella frescura della sera, allietava il respiro della gente e faceva loro dire: “Che bello vivere qui!”
Nasturzio, abituato fin da piccolo al sole, al sale e al rispetto che si deve al mare, decise: “Sarò pescatore”.
Comperò a rate (con i soldi di mamma Mimosa) una barchetta d’occasione: sei metri fuori tutto, di fasciame in legno, armata con una vela al terzo, e completa di un piccolo fuoribordo e un verricello di prua. Si chiamava Susy, col nome dipinto in uno svolazzante corsivo inglese. Ancor prima di sistemare alcune parti da ricatramare, cancellò il pericoloso nome femminile e scrisse, con solenni caratteri gotici: “MARIO”. Con Mario sotto il sedere si sentiva rilassato, fiducioso nell’affrontare acque calme e improvvisi fortunali.
Provvisto di reti da posta e nasse, Nasturzio Tremolucci, pescatore, salutò il suo mare e ne benedisse la generosità. Naturalmente mai avrebbe avuto il coraggio di vendere il pesce al mercato: tutte quelle donne urlanti, e le domande: “A quanto li fai i dentici, oggi? … E le spigole?” L’avrebbero annichilito e soprattutto non sarebbe stato in grado di rispondere. Si scelse un socio logorroico e avido che, dietro una cospicua percentuale, di prima mattina lo attendeva sul molo, caricava sull’Ape Car le cassette guizzanti di pesce vivo e raggiungeva il mercato.
S’è detto che Nasturzio conosceva il mare e l’incantamento della sua voce, svelato a pochi, e il liquido sussurrio impercettibile, e i suoi capricci, apparentemente immotivati. E il rispetto che a lui si deve. Sempre.
Imparò presto le dimore predilette dei suoi abitanti. Laggiù bisticciavano i branchi delle sardine e a tre miglia, a venti gradi a ovest, pigravano spigole e pagelli, mentre le orate se la godevano più oltre, quattro miglia a dritta, dodici gradi a est. Per le aragoste era facile: vicino agli scogli, come i polpi e le seppie.
Volarono inverni e primavere. Condannato a un’esistenza ingrata, Nasturzio in quella gabbia ci viveva, rassegnato. Infelice, ma ci viveva.
Mamma Mimosa gli fece compagnia fino a che lui batté i trentatré anni, quando ella morì, abbandonandolo nella disperazione. Gli lasciò un dolore irrecuperabile, un esiguo gruzzoletto, la casetta in riva al mare, un generoso orto esposto a sud e un pollaio esuberante di galline goderecce e prolifiche.
Nasturzio rispettò la sacralità del tocco femminile, teneramente eccessivo, che si respirava nelle due stanze, complete di cucina più servizi. Non toccò nulla. Risistemava di qualche millimetro, quando se ne ricordava, i centrini di pizzo sui mobili e nel centro tavola e non sfiorò mai i vasi di ceramica e di peltro che invadevano le mensole, così come non osò toccare mai, se non per spolverarli, e solo per le pulizie di Pasqua, i molti souvenir di gite perdute.
Si scopriva, la mattina, a salutare Pippo, il cane di pezza a cui mamma Mimosa era tanto affezionata: “È stato il mio primo amico d’infanzia”, ripeteva sempre lei. Pippo troneggiava nel centro del piano della credenza, in soggiorno, ingobbito eppure sicuro del suo ruolo. Mamma Mimosa lo salutava ogni mattina, ma solo dopo che Nasturzio, sbadigliante e in pigiama, s’affacciava in cucina.
“Buongiorno Nasturzio, buongiorno Pippo”.
Il figlio non era geloso, perché il primo saluto era per lui.
Un giorno chiese a mamma: “Quanto è vecchio Pippo?”
Lei disegnò con la mano un ampio semicerchio nell’aria e rispose:
“Erano ancora tutti vivi.”
Il cane di pezza, con l’unico occhio rimasto, che era un bottone nero, lucido e sferico, aveva assistito all’incendiarsi e consumarsi di due guerre mondiali e all’avvicendarsi di quattro generazioni, e udito scalpiccii proibiti, e risate ardite a stento trattenute, e azzardi di maldestri amanti. E la quiete irrisolta dei dì d’adesso. Seduto, sbilenco su un comodo cuscino guatemalteco affollato di uccelli stravaganti, osservava, dalla sua postazione privilegiata, allo snocciolarsi del tempo.
Ora che mamma Mimosa se n’era andata, Nasturzio era solo. Leggeva, fantasticava e attendeva il tramonto per postare le reti e fissare le nasse. Tornava a casa che la notte si stemperava nel mattino. Si riempiva un bicchiere di vino bianco e si cucinava un po’ di pesce. Leggeva qualche pagina di uno scrittore classico e si gettava sul letto, spesso ancora vestito.
Fu in una notte tormentata, e fu dopo molti tentennamenti che si persuase: avrebbe tentato la via dell’analisi del profondo.
Ogni martedì, con coraggio insolito, prendeva la macchina e per vie tortuose e solitarie raggiungeva la città vicina dove, alle quattro del pomeriggio, l’attendeva l’analista, un uomo anonimo con la stessa cravatta annodata stretta. Nasturzio espose la sofferenza del suo dolore e il professore parlò di rimozione, fissazione, regressione e sublimazione. Dopo un anno abbondante di trattamento, vessato dai sensi di colpa d’aver dilapidato parte dei soldi ereditati da mamma Mimosa, decise di piantarla lì. L’unico risultato che ottenne dalla terapia fu che smise di mangiarsi le unghie
Gli anni passavano e passavano. Nasturzio, valente conoscitore del pesce, divenne eccelso nel cucinarlo. Peccato che gli unici privilegiati a bearsi di tanto virtuosismo fossero i tre amici, i quali, con gioia, si prodigavano a racimolare gli ingredienti di cui difettava l’orto. Accadeva nelle notti di plenilunio, quando i pesci, aiutati dal chiarore, vedono le reti e ne stanno alla larga.
Capesante con crema di spinaci e zafferano, agnolotti di pagello, cipollotto dell’orto di casa (insuperabile!), e maggiorana, polpo croccante con crema di cavolfiore e sedano marinato… È questo solo un risicato Bignami, un minimo accenno di quanto fosse impareggiabile l’abilità gastronomica di Nasturzio.
Salutati gli amici, si chiudeva nella piccola casetta in riva al mare. Appoggiato alla finestra, scostava le tendine di organza di mamma Mimosa e guardava il frangersi delle onde nel biancore lunare, ne respirava l’umore che penetrava dagli stipiti malconci e ne seguiva il ritmo del loro andare e ritornare. Fantasticava d’invitare a cena donne avvenenti: si perdeva nei loro sorrisi e nel loro imbarazzato sdilinquirsi tra cotanta prelibatezza gastronomica.
… Se solo avesse trovato le parole per invitarle…
Poi sceglieva dalla biblioteca uno degli svariati capolavori che amava rileggere: Tolstoj, Proust, Kafka… Scorreva qualche pagina, che conosceva a memoria, ma che riassaporava ogni volta con passione. Talvolta finiva col cacciarsi davanti alla tivù e lì si addormentava fino a notte fonda, svegliato dall’imbonitore che vendeva Rolex falsi d’occasione.
Spesso Nasturzio, sul primo pomeriggio, in compagnia di Mario, vagava sul mare. Avviava il motore, salpava dal porto e raggiungeva una certa distanza, che riteneva ‘tranquilla’. Allora spiegava la vela e si lasciava trasportare dal vento. Si allungava sul fondo di Mario, chiudeva gli occhi e stava lì, steso nel sole. Talvolta stonava sottovoce vecchie ballate marinare in dialetto, e si assopiva. Mai troppo, ben inteso, perché in mare bisogna dormire con un occhio solo. Lo sbattere del vento sulla vela, il tremolio di una cima, l’odore e il rollio delle onde, o l’urlo di un gabbiano, gli concedevano requie al patimento costante.
Era il ventisei aprile, dopo pranzo, le tre appena passate, quando Nasturzio Tremolucci levò gli ormeggi: il declinare del giorno si preannunciava magnifico e la primavera avanzava generosa. Costeggiò le case colorate di fronte al porto e, sempre a basso regime, fiancheggiò, a debita distanza, la spiaggia.
Fu allora che fu sorpreso, (saranno stati, a occhio e croce, centocinquanta metri dalla riva), da uno scompiglio d’onde sconvolte, in un cerchio d’acqua non più ampio di due metri. Dalla schiuma affiorò un braccio, subito inghiottito dall’acqua. Ne apparve un altro ─ o era lo stesso? ─ che s’inabissò all’istante. Gli parve di scorgere una testa emergere e scomparire tra i flutti, e sentì chiaro il gorgoglio di un urlo.
Nasturzio virò immediatamente a dritta verso quella direzione, col motore al massimo. Raggiunse lo sventurato, già vinto dalle onde e tese una mano. Una mano lo afferrò, stringendola da fargli male, fino a ferirla. Lui la tenne salda e trascinò quel corpo inerme fin sul fianco di Mario e, con una forza insospettabile, lo trascinò dentro.
Era una donna.
Tossiva, sputava, ansimava.
La stese sul fondo accogliente di Mario. Gli occhi, ribaltati all’indietro, supplicavano aria. Tremava e Nasturzio la coprì alla meglio con una cerata, l’unica cosa che avesse in quel momento. I capelli neri, scomposti, le coprivano gran parte del viso, e ai lati della bocca le uscivano intermittenti fiotti di acqua e saliva.
Nasturzio, chino sulla donna, la guardava sgomento e, per la prima volta nella sua vita di pescatore, non sapeva che pesci pigliare.
Non era una situazione facile: una giovane donna a malapena coperta da uno striminzito bikini rosso, Mario, Nasturzio Tremolucci e l’infinità di un mare planetario.
La osservava tossire, sputacchiare e vomitare resti del pranzo. Passò un tempo che parve senza tempo. Lei, lentamente, si riprese. E ce ne fu.
Con gli occhi gonfi e semichiusi si guardò intorno, finché le si abbozzò sul viso una parvenza di lucidità: indovinò, nella liquidità che si stava svaporando, una silhouette maschile, china su di lei.
Scatarrando, bofonchiò:
“Lei… Mi ha salvato… La vita…”
Lui sorrise.
“Sarei morta… Se non ci fosse stato lei”, farfugliò in pieno delirio.
Nasturzio, sempre piegato su di lei, sorrise ancora. Lei continuava a tremare, e lui cercò di sistemare meglio la cerata, ma per quanto si prodigasse, il bikini rosso spuntava da tutte le parti. Fortunatamente il sole clemente del pomeriggio la riscaldava, indugiando sul bel viso, che piano riprendeva colore.
“Grazie”, continuava a ripetere, “Grazie”.
Sdraiata nella sicura concavità di Mario, riparata alla meno peggio dalla cerata, addolcì un sorriso e offrì la mano in segno di saluto:
“Mi chiamo Violetta”.
Lui la guardava, sempre piegato su di lei, e sorrise, inclinando di un nulla la testa.
“E lei, come si chiama?”
Nasturzio prese il suo quaderno, una biro e scrisse il suo nome. Violetta lo lesse, guardò lui e capì: l’uomo che l’aveva salvata era sordomuto.
“Non volevo offenderla”, disse.
Lui sorrise, accese il motore e s’avviarono verso la riva, e lei indicò il punto in cui aveva lasciato i vestiti.
“La voglio rivedere”, disse Violetta, abbigliata nell’abituccio da spiaggia a motivi etnici.
“Mi sente, vero?”, aggiunse imbarazzata.
Nasturzio annuì.
“Le va se ci vediamo al Bar Centrale alle sei?”
Lui scrisse sul quaderno: “Potrebbe andare un bar meno nell’occhio?”
Violetta pensò che il suo salvatore avesse una fidanzata, o una moglie gelosa.
“Ci possiamo incontrare da Sandruccio. Sa dov’è? Fanno dei cocktail meravigliosi”.
Lui annuì.
“Alle sei, allora”, e Violetta corse via.
Nasturzio, impaperato come non mai, s’avviò verso casa. Non aveva nessuna intenzione di incontrare quella donna, né al Bar Centrale, né da Sandruccio. Tanto più che lui e Mario, alle sei, prendevano il largo per gettare le reti e fissare le nasse. Prese un libro e si mise comodo sul divano: non riuscì a memorizzare neppure una riga: le parole che leggeva erano Violetta, Violetta, Violetta. Lavò i piatti sporchi, ma Violetta se ne stava là, effigiata nell’etichetta del sapone liquido. Aprì la credenza e da dentro gli sorrise il viso di Violetta. Esasperato accese la televisione: la speaker era Violetta. Decise d’uscire. Aprì la porta e gli venne incontro Picasso, il cane dei vicini: anche Picasso aveva la faccia di Violetta.
Alle quattro e cinquantuno prese la decisione che gli avrebbe cambiato la vita: decise di andare all’appuntamento. Al diavolo Mario, al diavolo la pesca, la diavolo spigole, saraghi e compagnia bella. Si fece una doccia, si sbarbò, si lavò i capelli, li asciugò cercando inutilmente di coprire le striature bianche sulle tempie e si cosparse un po’ dappertutto con un profumo che forse vent’anni prima aveva regalato a mamma Mimosa.
Anche Violetta si fece bella: bagno in vasca con cristalli di sale dell’Himalaya, maschera rivitalizzante al collagene e vitamine, crema rassodante, latte doposole all’aloe vera, lacca per capelli effetto ‘umido’, smalto turchese alle unghie di mani e piedi, un velo discreto di trucco e due gocce di Guerlain Insolence sull’incavo dei polsi e dietro i lobi delle orecchie. Indossò una vaporosa gonnellina bianca, gentilmente acquerellata con ghirigori cerulei, accompagnata da un’impalpabile camicetta di seta. Si mise al collo una collana d’argento con coralli giapponesi e schegge di topazio imperatore, e già alle cinque e mezzo si mise in cammino.
Nasturzio partì prima, alle cinque e dodici minuti esatti. Imboccò vicoletti scuri e traverse quasi sconosciute. Rabbrividì quando vide avvicinarsi una donna.
“Sa che ore sono, per favore?”
Lui sollevò il polsino della camicia bianca stirata di fresco e scoprì l’orologio, che avvicinò alla donna.
“Molto gentile”.
Nasturzio sorrise.
Alle sei meno dieci s’incontrarono all’entrata del Bar Sandruccio.
“Sono in anticipo. Oggi il mio orologio ha fatto indigestione d’acqua”.
Nasturzio indicò il polso e alzò gli occhi e le spalle: per lui voleva dire: “Anche il mio ha bevuto troppo”.
“Lo so” disse Violetta che capì, “abbiamo due orologi beoni”.
Si accomodarono in un tavolino appartato.
“Le posso offrire qualcosa? Un Alexander? Un Mojito? Quello che vuole”.
Nasturzio indicò la macchina del caffè, prese il quaderno e scrisse: “macchiato, grazie”.
Violetta s’avvicinò al bancone e per lei ordinò un Negroni.
Restarono in silenzio, molto in silenzio. Finalmente arrivarono il caffè e il Negroni. Violetta disse, nel sorseggiarlo: “Ne avevo bisogno, dopo quello che mi è successo”.
Lui sorrise. Ancora silenzio. E silenzio ancora. Nasturzio non resistette. Prese il quaderno e scrisse: ”Una volta sapevo parlare”.
“Come… Lei … cioè tu… tu sapevi parlare?”
Lui scrisse: “Un giorno le parole presero ad incepparsi, e non uscirono più. Mi capita solo con le donne”.
“Nasturzio… non puoi… uno come te, non è possibile”. Gli afferrò la mano e gliela strinse forte. “Ci deve essere un metodo”.
Lui prese la penna: “Non c’è speranza, sono condannato”.
“Non ci credo! Guardami, Nasturzio! E ora guarda il tuo caffè e prova a dire: “CAFFE’”, ti prego, prova… prova…”
Nasturzio Tremolucci sudava e più s’asciugava il sudore col tovagliolo di carta, più sudava, con i capelli incollati alla fronte e la camicia zuppa.
“Prova, Nasturzio, prova! Caffè! C-A-F-F-E’!”
Lui prese fiato più volte, girò la testa da una parte all’altra, con la bocca aperta, ansando, a invocare ossigeno, chiuse gli occhi tanto da schiacciarli, corrugò la fronte fino all’apparire di rughe sconosciute, afferrò tutta l’aria del mondo e balbettò in una minima voce di bambino:
“C… C… Ca… Caf… Caf… Caffè”.
Nasturzio s’accasciò sfinito sul tavolo e Violetta applaudì e urlò che tutti si volsero:
“Ce l’hai fatta! Hai vinto! Hai vinto, Nasturzio!” Lo sollevò dalla sedia e lo baciò sulla fronte: con lo schiocco, che tutti lo sentirono.
“Usciamo!” Violetta gli prese la mano e appena fuori si fermò davanti alla prima cosa che vide, un grande albero.
“Albero, Nasturzio, A-L-B-E-R-O. Ti prego, Nasturzio, dillo!”
“A… A… Alb… Alb…”
“Dai! Ce la puoi fare, ancora un piccolo sforzo”.
“Alb… Alb… Alb… Albero”.
“Oh! Nasturzio, sei magnifico!” e lo baciò sulla bocca: con lo schiocco, che lo sentirono fin dentro al Bar.
“E vedi quella?”, disse eccitata Violetta indicando una casa, “è una casa… C-A-S-A”
“C… Ca… Ca… Ca… Casa”.
“Splendido: caffè, albero, casa”. E lo baciò, più e più volte, sempre con lo schiocco: al Bar non ne potevano più di tutti quelli schiocchi.
Nasturzio guardava gli occhi belli di Violetta e Violetta ricambiava lo sguardo, incrociando gli occhi belli di Nasturzio. La brezza gentile d’aprile s’intrufolava delicata tra i capelli di lei e la gonnellina leggera se ne andava birichina un po’ per i fatti suoi. Si salutarono con un infantile bacio sulla guancia. Il sole ingentiliva di tocchi rosati le cose.
“Domani, stessa ora, stesso posto?” propose piena di speranza Violetta.
“Caffè… Albero… Casa…”, rispose Nasturzio. Era un sì.
Si dimenticarono di pagare.
Violetta corse a casa felice.
Nasturzio corse a casa felice.
Violetta telefonò immediatamente alla sua migliore amica, Bucaneve:
“Ho incontrato un tipo meraviglioso, vediamoci domani sul mezzodì, che ti racconto”.
A ora di cena, il telefono di Nasturzio suonò. Lui, eccitato com’era, non si curò di controllare sul display chi chiamasse: di solito, se leggeva ‘sconosciuto’, non rispondeva: poteva essere una donna, non si sa mai! Alzò la cornetta:
“Salve, sono Albertina, della premiata ditta di materassi ‘Sogni d’oro’. Abbiamo strepitose offerte appositamente studiate per lei…”
L’interruppe Nasturzio: “Caffè… Albero… Casa…” E riattaccò.
Batteva mezzogiorno e il sole brillava sul borgo.
Violetta e Bucaneve erano sedute al Bar. Violetta raccontò all’amica dello scampato pericolo in mare e poi parlò di Nasturzio:
“Lui è stupendo. Timido, impacciato a volte, fragile, ma stupendo. Credo di essermi presa una cotta. Di quelle toste”.
“Felicità!” esultò Bucaneve “sono felice per te! Brindiamo. Per me un frizzantino, e tu?”
“Veramente mi sono alzata da poco. Avrei voglia di un buon… di un buon… “ Non riusciva a dirlo. Indicò la macchina del caffè e aggiunse angosciata: “lungo”.
L’assalì lo sgomento.
“Vieni fuori!” Ordinò a Bucaneve.
Uscirono.
“Vedi quello?”, Violetta indicò l’albero: “Quello è… Quello è…”
“Ti senti bene? commentò preoccupata Bucaneve.
“Tutto OK, tutto OK”, mentì Violetta, che proseguì “La vedi anche tu quella cosa lì, dipinta di giallo?” E puntò l’indice verso una casa, “È una… Cristo, è una… Una… “
“Sei sicura di sentirti bene?” Insistette Bucaneve nel vedere l’amica sempre più pallida.
“Sì, scusa, va tutto bene, solo che devo correre a… cosa. Scusa”.
Si dimenticarono di pagare.
Violetta si gettò sul letto e pianse: le tre parole che aveva insegnato a Nasturzio non c’erano più. Cosa sarebbe successo quando quel pomeriggio avrebbe insegnato a Nasturzio altre tre parole? Di lì a poco s’immaginò senza parole. L’uomo che le aveva ridato la vita, le toglieva la possibilità di vivere, di dire: ‘Ehi! Ci sono anch’io’.
Il cuore di Nasturzio Tremolucci ballava la rumba. Aveva appena infornato un’orata al sale e piroettava per la casa, accompagnando con tentativi di tip-tap il ritmo caraibico del battito cardiaco, ripetendo all’infinito: “Caffè… Albero… Casa… Caffè… Albero… Casa…”
Pranzò in fretta e uscì. Timido e insieme eccitato, s’intrufolò nelle stradelle solitarie che conosceva, strette tra vecchie case. Rabbrividì nel vedere avvicinarsi una donna. Cercò di scantonare a destra, a ridosso dei muri, ma lei s’indirizzò dritta su di lui: rotta di collisione.
“Scusi, mi sa dire l’ora?”
Nasturzio fu lì lì per porgere il polso con l’orologio vicino alla donna quando, guardata l’ora, disse:
“Sono le tre meno un quarto”.
“Grazie.”
“Si figuri”.
La donna voltò l’angolo e lui si sedette per terra, si prese la testa fra le mani, alzò gli occhi al cielo, e rise, rise, rise.
E rise fino a che finirono le lacrime.
“So parlare alle donne! Io so parlare alle donne!”
Raggiunse il Corso principale. Non era l’ora dello struscio, ma qualcuno passeggiava. Fermò la prima ragazza che incrociò e le annunciò: “Sono le tre e due minuti.” Corse a più non posso finché bloccò una donna di mezza età: “Sono le tre e undici minuti”. E continuò, continuò, finché, col fiato grosso, tornò a casa.
Aveva segnalato l’ora a diciannove donne diverse (più due bambine).
Attese con ansia le sei, l’appuntamento con Violetta.
Gli venne lo sghiribizzo di comprarsi un abito nuovo. Entrò baldanzoso in negozio e conversò sicuro con la commessa: “Lo vorrei così e così”.
Corse a casa e aspettò impaziente, perfetto nel vestito nuovo, d’incontrare Violetta.
Alle sei meno dieci s’incrociarono sull’entrata del Bar Sandruccio. Risero, perché la scusa dell’orologio annacquato non contava più. Lui, impeccabile nella giacca di lino stropicciato beige su pantaloni navy, lei nell’abito di ieri.
Si sedettero al solito tavolo.
“Non ci dobbiamo più vedere”, disse lei, e una lacrima le rigava la guancia.
“Violetta, tu mi hai dato la vita. Sei la mia vita”.
Lei si meravigliò, perché Nasturzio sapeva parlare.
“Sì: so parlare, me l’hai insegnato tu. Ti voglio bene. Brindiamo alla nostra felicità”.
Violetta, confusa, avrebbe voluto dire di quanto fosse contenta per la prodigiosa conquista di Nasturzio, ma fu soltanto in grado di indicare la macchina del caffè: “Lungo…”, aggiunse mestamente.
A Nasturzio un presentimento gli raggelò il cuore.
“Piccola mia! Ti ho rubato il caffè. Dio sa quanto non volevo farti del male. Prova, tesoro, prova a dirlo: Caffè… C-A-F-F-È. È facile. Ce l’ho fatta anch’io.”
“C… C… Caf… Caf… Caffè”.
“Visto com’è semplice, Stellina mia?”
“Usciamo, ti prego”, e la prese per mano.
Indicò l’albero. “Dimmi cos’è”.
“… “
“Albero”, ce la puoi fare, “A-L-B-E-R-O”.
“A… A… Alb… “
“Ancora, piccola, non è finita, ce la fai, ce la fai…”
“A… A… Alb… Alb… Albero”.
“Dio del cielo, sei meravigliosa, e dimmi, quella cos’è?” E indicò la casa.
“… “
“C-A-S-A… C… Ca… Casa… Prova, amore, è facile”.
“C… Ca… Ca… Ca… Casa…”
“Visto? E’ naturale”. E la baciò sulla fronte, sulle guance e sulle labbra.
“E’ bellissimo”, proseguì Nasturzio, “ Quello è un…, e quella è una…, e, accidenti, mi sono dimenticato di pagare il… “
Si guardarono turbati.
“Oh! Nasturzio! Tu mi hai ridato il caffè, l’albero e la casa. Come farai senza? Non posso accettare”.
“Non ti preoccupare, Tesoro. Quello”, e indicò l’albero, “lo chiamerò col suo vero nome: faggio, abete, quercia, larice…, e quella”, e si rivolse alla casa, “sarà un’abitazione, un edificio, una palazzina, una costruzione… In quanto alla bevanda nera, ho deciso di smettere di berla: mi rende nervoso e m’inquieta le notti”.
“E tu rinunci all’albero, alla casa e al caffè? Tutto questo per me?”
“È il prezzo dell’amore, bambola”. Nel dirlo cercò d’impostare la voce come un attore.
Cingendosi l’un l’altra il fianco, s’allontanarono dal Bar, dimenticandosi di pagare, e andarono incontro al tramonto d’aprile.
Lui parlava e parlava: “Guarda quel platano” indicava “e guarda, laggiù, com’è alto quel pino marittimo, e quanto è bello questo edificio azzurro, con i gerani rossi che pendono dai balconi”. Lei lo ascoltava, mentre s’inoltravano abbracciati in un intrico di vicoletti discreti. E lui iniziò, perché da sempre lo avrebbe desiderato fare di fronte a una donna, e soprattutto di fronte alla donna che amava:
“Abaco, abate, abbacchio, abbecedario, abbuffata…” E avrebbe proseguito fino a zanzara, zucchina, zufolo, zuppiera e zuzzurellone, se Violetta non l’avesse interrotto:
“Amore, avrai il tempo di dire tutte le parole che vorrai, e io ti ascolterò”.
“Lasciami pronunciare le ultime, Stella mia, è una vita che volevo dedicarle alla mia donna: epistemologia, sineddoche e apotropaico”. Non ne conosceva il significato, ma intuiva che nel mare ancora inesplorato, da qualche parte, al riparo di uno scoglio, esse si nascondessero, in attesa che qualcuno le celebrasse.
Mario, che Nasturzio ribattezzò Violetta, (ma Mario non se la prese), li avrebbe accompagnati dove nuotano tutte le parole conosciute, sconosciute ed estinte, e là, un giorno, le avrebbero viste guizzare dall’acqua, come pesci volanti:
Epistemologia,
Sineddoche,
Apotropaico.